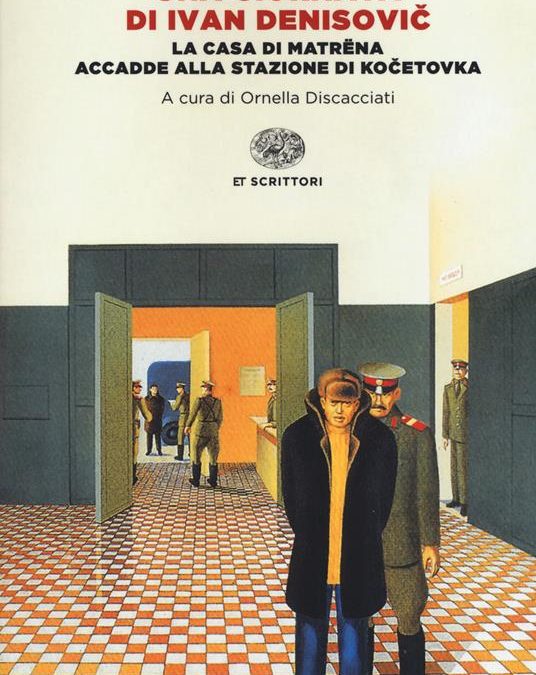Mag 12, 2022 | Newsletter, Rassegna stampa
Associazione Italiana Centri Culturali, Centro Culturale di Milano e Il Rischio Educativo, con la collaborazione di Diesse, Disal, Foe, e Portofranco, hanno ideato un’iniziativa per il Centenario di don Luigi Giussani, incentrata su uno dei temi che gli stavano più a cuore: l’educazione.
“Educare oggi. La proposta e il metodo di don Luigi Giussani” è una serie di quattro incontri, in forma dialogica, organizzata per discutere, confrontarsi, conoscere una proposta educativa tra le più interessanti del ‘900 e dei nostri giorni.
- Giovedì 21 aprile “Il metodo educativo” – relatore Julian Carron
- Giovedì 5 maggio “Autorità e libertà” – relatore Antonio Polito
- Giovedì 12 maggio “Verità e realtà” – relatrice Luigina Mortari
- Giovedì 19 maggio “Tradizione e verifica” – relatore Giorgio Chiosso
Un’iniziativa aperta a tutti quelli che nella società e nella scuola sentono con sincerità l’importanza dell’educazione come dimensione cruciale nello sviluppo umano, dalla prima età all’età adulta, affinché la persona emerga come protagonista della vita sociale e culturale.
Nel mondo della scuola e della formazione, e anche in quello dell’Università, si concentrano le sfide del cambiamento antropologico che viviamo e dove, dunque, si riscontrano le testimonianze di un cammino umano, fatto di tentativi, riprese, impegni, sacrifici, per dare consistenza alla dimensione educativa. Il bisogno educativo è avvertito a livello globale, proprio nelle crisi e nelle riduzioni dell’umano che la società contemporanea sta attraversando.
È stato chiesto a esponenti del mondo della scuola, dell’università, della comunicazione, della vita sociale, di confrontarsi con i testi di don Giussani sull’educazione, a partire dal suo scritto principale, Il rischio educativo.
Sono stati attivati focus di discussione che, a partire da letture attente dei testi, pongano in rilievo le idee educative di don Giussani e, attraverso un paragone serrato con l’attualità, ne verifichino l’attualità e il valore, aprendo domande e scoprendo nuove problematiche.
La riflessione sarà sostenuta anche dal confronto con esperienze educative, personali e collettive.
Ogni incontro vedrà la partecipazione di un keynote speaker, che dialogherà con i curatori del ciclo e con alcuni discussants.
fonte: sito del Centro Culturale di Milano LUIGI GIUSSANI CENTENARIO DELLA NASCITA (1922-2022) | Centro Culturale di Milano

Mag 12, 2022 | Invito alla lettura, Newsletter
Aleksandr Isayevich Solzenicyn (1918 – 2008)
Dissidente russo ai tempi dell’Unione Sovietica, ma che ha vissuto per circa vent’anni negli Stati Uniti.
Se, come dice l’autore, “Gli unici sostituti di una esperienza che non abbiamo mai vissuto in prima persona sono l’arte e la letteratura”, questo è uno dei libri che vanno letti.
Si tratta di un romanzo ambientato in un ospedale dove curano il cancro, malattia per la quale lo stesso Solzenicyn è stato curato. Pur essendo un vero romanzo, il libro è cosparso senz’altro di sfumature autobiografiche, di esperienze che lui stesso ha vissuto. Ci sono tanti personaggi, che rivelano in fondo ognuno di noi di fronte all’ineluttabilità della vita e della morte.
Magistrale è il cap. XXX nel quale una donna medico, primaria del reparto, scopre di essere a sua volta malata di cancro e va a trovare il suo vecchio insegnante. In quel colloquio traspare, attraverso pennellate magistrali, ciò che più conta e per cui viviamo… e accettiamo di morire: le relazioni umane.
Michael Dall’Agnello
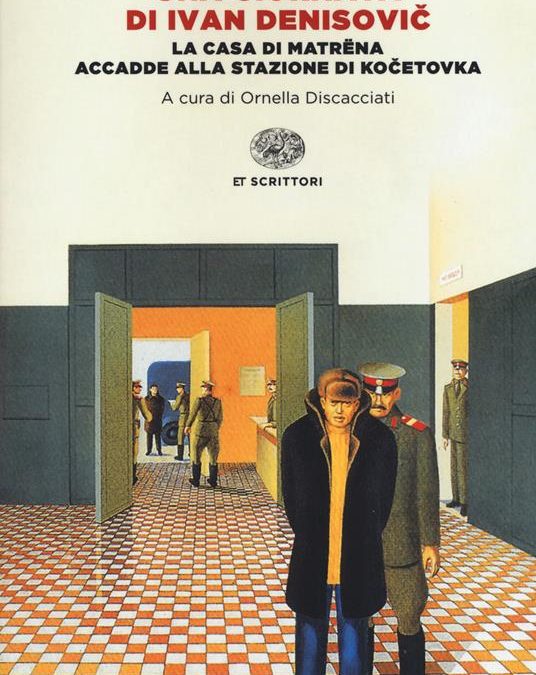
Mag 12, 2022 | Invito alla lettura, Newsletter
Aleksandr Isayevich Solzenicyn (1918 – 2008)
Dissidente russo ai tempi dell’Unione Sovietica, ma che ha vissuto per circa vent’anni negli Stati Uniti.
Il libro racconta con stile semplice, senza enfasi, una qualunque giornata di un detenuto qualsiasi all’interno di uno dei tanti campi di concentramento stalinisti sparsi per la Siberia. Solzenicyn narra le “gesta” di Ivan, che cerca, come tutti gli altri 364 giorni dell’anno, di non morire di fame o di freddo, ma soprattutto di restare un uomo e come ciò sia necessario proprio per non morire di fame o di freddo. Un episodio di particolare rilievo narra di come gli stessi internati siano costretti a costruire, con temperature proibitive e pochi strumenti, un muro inutile. Per rimanere uomini e in un certo modo “liberi”, questi hanno fatto di tutto, anche ciò che non era consentito, per compiere un lavoro ben fatto, correndo pure il rischio di essere puniti.
In questo testo, come in tutti i suoi scritti, traspaiono l’umanità e la profondità dell’autore, anche da un punto di vista educativo, e ci ricorda che ogni uomo, anche il più cattivo, rimane pur sempre un uomo, idea indispensabile anche oggi.
Michael Dall’Agnello

Mag 12, 2022 | Articolo di fondo, Newsletter
La guerra in Ucraina trae origine dallo scontro ideologico che si è venuto a creare tra Russia e Occidente negli ultimi 30 anni. Non si deve fare l’errore di pensare che l’ideologia sia una sorta di sovrastruttura stesa sopra le vere ragioni della guerra, quelle economiche, geopolitiche, militari. In realtà c’è una linea di continuità diretta tra la spersonalizzazione dell’altro, la costruzione del nemico e la decisione di scendere in guerra contro questo nemico, di bombardare le sue case, di sconvolgere la sua vita.
Il punto da cui occorre partire è l’appartenenza di Russia e Ucraina (e delle loro classi dirigenti) all’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, uno Stato totalitario fondato su di un’ideologia, cioè una costruzione intellettuale in cui alcuni elementi vengono presi dalla realtà e distorti a beneficio del proprio gruppo di appartenenza.
Nel 1991 crolla l’Unione Sovietica e per la Russia cominciano i selvaggi anni Novanta: arriva l’economia di mercato occidentale, anzi il capitalismo selvaggio in cui prevalgono i più spregiudicati, gli oligarchi. Nel 2000, quando El’cin passa la mano a Putin, la situazione cambia radicalmente: Putin dichiara guerra agli oligarchi, emana alcune riforme decisive, sorge la classe media russa, la ricchezza si diffonde. Contemporaneamente Putin si mette a capo del recupero russo dei valori tradizionali, si presenta come il leader mondiale del conservatorismo non islamico, restituisce alla Russia il suo status di potenza mondiale, ma verso il 2012 piega questo recupero simbolico verso il passato sovietico ed impone una sola verità storica e culturale, la verità di Stato. La chiusura delle emittenti televisive di proprietà degli oligarchi, la guerra fatta ai giornalisti indipendenti (Politkovskaja, Estemirova ecc.), la chiusura di Memorial sancisce l’affermazione del pensiero unico in Russia.
Il percorso dell’Ucraina fuori dall’Unione Sovietica è stato diverso da quello russo. Divisa per secoli tra Impero Zarista e Impero Austro-Ungarico, presenta ancor oggi una parte occidentale decisamente ucrainofona, prevalentemente agricola e spesso di confessione cattolica e una parte orientale molto più russofona, ortodossa e di antica tradizione industriale. E, pur essendo una regione ricca di risorse naturali e agricole, non è mai riuscita decollare nel periodo post-sovietico, soprattutto per l’insediarsi al potere di una élite economico-politica: qui gli oligarchi non sono mai stati estromessi dal potere politico e continuano a spadroneggiare.
La debolezza dello Stato è certificata dalla continua discussione sulla Costituzione, modificata più e più volte, contestata e, soprattutto, più volte disattesa. Ma è certificata anche dal potere che nel 2014 viene concesso alle manifestazioni di piazza avvenute col consenso e la partecipazione palese degli USA. Alla fine di febbraio il presidente filo-russo Janukovič, pur essendo stato regolarmente eletto, viene defenestrato e sostituito, il tutto in un clima di accuse reciproche, ma soprattutto senza alcun rispetto per la Costituzione e lo Stato di diritto.
È la scintilla. Alcune regioni a maggioranza russofona non accettano il neonato governo Jacenjuk voluto dagli USA e prontamente riconosciuto invece dal mondo occidentale. La Crimea – regione militarmente strategica – dichiara con un referendum la propria volontà di staccarsi dall’Ucraina e aderisce alla Russia. Stati Uniti ed UE proclamano le sanzioni alla Russia e ai politici russi che avevano approvato quel referendum. Un mese dopo due regioni a maggioranza russofona della zona orientale, il cosiddetto Donbass, si ribellano al governo centrale ucraino e si costituiscono nelle Repubbliche secessioniste di Donec’k e di Lugans’k.
Da quel momento in Russia e in Ucraina – ma anche in Occidente – si strutturano due interpretazioni ideologiche contrapposte che ispirano le politiche militari, linguistiche, mediatiche.
Le autorità ucraine mettono in campo un’Operazione Anti Terrorismo in cui intervengono formazioni paramilitari di matrice estremista (Pravyi sektor); seguono tentativi internazionali di conciliazione, fasi di escalation, de-escalation, perdite e riconquiste di territori, il trattato Minsk I (settembre 2014) e Minsk II (febbraio 2015) mai pienamente implementati, elezioni non legittime, manifestazioni a favore delle diverse soluzioni filo-separatiste e filo-governative, una fase di stanca nel 2016. Nel 2018 il governo ucraino decide di non tollerare più la situazione e riclassifica l’Operazione Anti Terrorismo in Operazione Militare Congiunta: non sarà più la polizia a lottare contro i separatisti filorussi, bensì l’esercito ucraino al comando del presidente si schiererà contro quella che è senza alcun dubbio l’aggressione armata di una potenza straniera, la Russia.
Nel mezzo, a gettare benzina sul fuoco, la cessazione dell’erogazione delle pensioni da parte dell’Ucraina agli anziani delle repubbliche separatiste e l’assunzione dell’onere da parte russa (2014), l’orribile strage dei manifestanti filorussi a Odessa (maggio 2014), l’abbattimento del volo delle Malaysian Airlines 17 da una postazione dei separatisti (luglio 2014), due navi militari ucraine catturate dai russi mentre cercavano di forzare lo stretto di Kerč (novembre 2018). Nel 2019 il conteggio di questa “guerra a bassa intensità” supera i 13.000 morti , di cui oltre 3.300 tra i civili, mentre i feriti ammontano ad almeno 7.000.
Anche qui si fronteggiano due narrazioni. L’una è quella che ha fornito direttamente il presidente Putin nel discorso del 21 febbraio 2022 quando ha detto che, nel 1922, “il Donbass, fu letteralmente ficcato dentro l’Ucraina” e che quello che è avvenuto in questi 8 anni di bombardamenti con droni d’attacco, attrezzature pesanti, razzi, artiglieria e sistemi di razzi a lancio multiplo “è interamente un prodotto del colpo di stato del 2014”. Che, dunque, per risolvere la questione del Donbass, non resta altra soluzione che riconoscere l’indipendenza e la sovranità della Repubblica Popolare di Donec’k e della Repubblica Popolare di Lugansk e intervenire militarmente.
L’altra interpretazione dice che è inaccettabile che una potenza straniera, la Russia, entri con il proprio esercito nei territori di uno Stato sovrano, l’Ucraina, che fomenti azioni militari nelle regioni di frontiera di un paese confinante, e che il fatto che in quelle regioni vivano abitanti russofoni cui vengono conculcati alcuni importanti diritti identitari non è una giustificazione. C’è da aggiungere il silenzio che i mass-media, per lo meno quelli italiani, hanno riservato a questa tragedia, perché 13.000-14.000 morti sono comunque una tragedia, eppure questi morti sono stati trattati come morti di serie B, non degni delle prime pagine dei giornali, né delle aperture dei telegiornali.
Il resto è la terribile cronaca di questi giorni con l’esercito della Russia che invade l’Ucraina, semina morte e distruzione, e con un presidente Putin, che in nessun modo può essere giustificato dalle ragioni che abbiamo portato fino ad ora.
C’è da aggiungere solo che, se la catastrofe di cui siamo testimoni è il frutto delle ideologie portate avanti dalle classi dirigenti, dalla vita del semplice popolo ucraino viene invece un messaggio di speranza. Da decenni la popolazione ucraina aveva superato le ideologie nazionaliste, aveva mostrato come si convive in un paese con tanti matrimoni misti, che peraltro nessuno considerava misti. Viveva, la popolazione ucraina, senz’ombra di intolleranza tra ucraini e russi, utilizzando indifferentemente una lingua o l’altra, o un misto tra le due. Viveva in pace.
La politica ha l’obbligo di trovare le forme istituzionali di questa pace, assicurando larghi diritti alle minoranze, permettendo l’uso delle lingue minoritarie ovunque ci siano, aprendo scuole e università bilingui, aiutando le ragioni della convivenza, non costruendo ideologie che separano, armano, versano sangue. I politici ucraini devono superare il paradigma nazionalista, convincersi che non possono obbligare i russi del Donbass a studiare solo in ucraino e i politici russi devono convincersi che la Crimea può trovare la propria casa anche in Ucraina, come il Sud Tirolo l’ha trovata in Italia ed ha accettato di farsi chiamare Alto Adige.
La politica deve servire la pace che c’è. Deve imparare dalle famiglie che vivono in pace, non armare i fratelli contro i fratelli.
Giuseppe Ghini – professore ordinario di slavistica presso l’Università di Urbino

Mag 12, 2022 | Articolo di fondo, Newsletter
Intervista a Michele De Beni – Pedagogista-psicoterapeuta
1. La guerra è ora al centro dei nostri pensieri. Dopo tre anni in cui non si parlava che di virus, si è passati ora ad un altro tema, la cui complessità non è minore dell’altra. Se la cosa crea angosce e paure in un adulto, tanto più lo fa in uno studente, ragazzo o bambino che sia. Quali suggerimenti dare al mondo dell’educazione, che non può esimersi dall’affrontare, con mezzi adeguati alle varie età, questa tematica?
Dobbiamo riconoscere che il conflitto costituisce parte del nostro essere, insito nelle culture, nella politica, nell’economia…Percezioni, punti di vista, obiettivi contrastanti, che occorre saper ben gestire. Perché, di per sé, il conflitto non è guerra. Se ben affrontato, è preziosa via di dialogo per nuove comprensioni e soluzioni, per la pace e per il progresso. A volte, però, conflitti non ben affrontati possono sfociare in gravi tensioni e in guerre. Dobbiamo tenacemente opporci ad una cultura di guerra: non siamo condannati alla guerra, perché la nostra stessa specie è capace anche di inventare la pace. Sui social ingiustizie e prepotenze, però, ne fanno da padrone, scandite da un’ossessiva enfasi mediatica. Non dimentichiamoci, allora, che più di tante spiegazioni razionali sulla guerra, la via educativa più immediata è di spostare l’ottica dalla violenza alle ragioni e alle vie della pace. Questo non significa trascurare la conoscenza dei fatti e dei contesti dei crimini in atto. È sempre importante aiutare i bambini ad esprimere ciò che hanno dentro e che li incuriosisce. Ma ciò va accompagnato e regolato in giuste proporzioni, in base all’età e alla sensibilità di ciascuno. Se per quelli più grandi è possibile, e in certi contesti pedagogicamente doveroso, iniziare un graduale approccio a un tema complesso come la guerra, per i più piccoli occorre stare attenti ad un tipo di esposizione mediatica che li potrebbe ferire. Serve più rispetto per l’infanzia! Qui, però, vorrei richiamare la priorità di far sperimentare buone pratiche di comunicazione in famiglia, a scuola, nel gruppo. È in questo modo che insieme si scopre la forza e la bellezza del dialogo e, all’opposto, quanta disumanità, distruzione e solitudine provochino l’odio e la sopraffazione. Sarebbe questo un passo decisivo nel segno della prevenzione e della pace. Più bambini e più ragazzi imparano a ben gestire i loro litigi quotidiani più impareranno cosa sono gli orrori della disunione e della guerra.
2. L’uniformità, l’omologazione e la mancanza di vedute discordanti sono sintomo di una dittatura. La diversità di opinioni, il litigio, il confronto, anche con toni accesi, è invece fisiologico in una società libera. Come valorizzare l’importanza dello scontro dialettico e del dibattito come strumento di prevenzione della guerra?
Se c’è una colossale ignoranza da correggere oggi è quella riguardante la gestione dei conflitti, che certi squallidi talk show condotti alimentano ad arte sul filo di un’accanita aggressione verbale. Cosa se ne può trarre, a nostra volta, se non una martellante propaganda di delegittimazione dell’avversario? Non è questa scuola quotidiana di violenza? Qui non c’è rispetto della persona, né si permette ai diversi punti di vista di esprimersi, ma si persegue scientemente l’obiettivo dello scontro e della rissa. In questo modo non ci può formare un’opinione in merito ad un argomento, che sempre andrebbe compreso nella sua complessità avendo a disposizione più fonti d’informazione e diversi punti di vista. Questo non succede nelle dittature o nelle forme autocratiche di governo dove ogni dissenso è censurato e punito. In questi Stati la gestione violenta del potere arriva alla spersonalizzazione fino alla soppressione fisica dei cittadini, spogliati dei loro elementari diritti di libertà e di parola. Senza arrivare a queste forme dittatoriali, però, mi sembra che nel nostro contesto culturale democratico si stiano attraversando due grossi pericoli: il primo è quello di una sovraesposizione mediatica alla violenza, che certamente non è buona “maestra” di sana comunicazione e di pace; il secondo pericolo, conseguente al primo, è che nelle nostre conversazioni quotidiane, in famiglia, a scuola, in politica… non si è sufficientemente attenti a quella pedagogia di ascolto e di dialogo che sono precondizioni indispensabili per la ricerca di soluzione dei conflitti. Se una dittatura comporta l’impossibilità di un confronto tra una pluralità di punti di vista, il rischio che corrono le democrazie è di una pseudo-dittatura della disinformazione. Essa, fatta abilmente circolare attraverso una martellante quantità ripetuta di dati falsi o distorti, condiziona la mente a non praticare quell’indispensabile esercizio di ricerca e di verifica delle informazioni che sta alla base di ogni vera democrazia, dell’intelligenza umana stessa. Il rischio ormai è che nessuno più crede a niente e a nessuno. Questa è la fragilità di una cultura debole che non aiuta al confronto e che asservisce al pensiero dominante. Questa è la peggior forma di dittatura a cui dobbiamo reagire, introducendo nelle nostre scuole progetti mirati ad insegnare a pensare con la propria testa e a dialogare.
3. I bambini si sentono particolarmente impotenti di fronte ad un male così grande. Come durante la pandemia, il Santo Padre non ha mancato anche in questa occasione, in particolare durante la festa dell’Annunciazione il 25 marzo, di ricordarci che un mezzo sempre potente per fermare le calamità (naturali e artificiali) e per renderci protagonisti della pace sia la preghiera. Ma come essa oggi è possibile quando tutto sembra crollare, senza speranza?
Le radici storiche e religiose di un conflitto fratricida da “Terza guerra mondiale a pezzi”, evocata a più riprese da papa Francesco, si sta drammaticamente componendo in Ucraina. Dovremmo interrogarci sul ruolo che ha la religione non solo in questa guerra, ma in tutte le forme di conflitto. La disunità tra cristiani e tra chiese, nella nostra stessa Comunità cattolica, dovrebbe risuonarci dentro come il tradimento più scandaloso dato al mondo: quello di farci scudo del Vangelo senza impegnarci a viverlo. Chiusi in diatribe ideologiche e di bottega abbiamo chiuso mente e cuore al dolce ma esigente invito di Vita che ci viene dalla Parola di Dio. E ci siamo dimenticati che Dio è intima vocazione dell’uomo, di ogni essere umano sulla terra, come lo è il sogno di felicità, di amore, di pace che dall’Eterno è inscritto nel nostro DNA, di qualsiasi religione e cultura noi siamo. L’enciclica Pacem in terris di Giovanni XXIII fu indirizzata a tutti, non solo ai cristiani, a tutti gli uomini e donne di buona volontà, come appello a unire tutti gli sforzi per ricomporre la pace sull’orlo di una guerra tra Russia e USA. Era il 1963, ma questa enciclica mi sembra di grande attualità perché ci riconduce a drammi simili che, pur in contesti storici diversi, sta attraversando la nostra società globale, come quello di uomini e donne, di bambini massacrati a Mariupol, a Kharkiv, a Kiev, a Chernihiv…
4. Rivolgersi a Dio nei momenti difficili è quasi spontaneo. Ma di fronte a tanto dolore oggi nel mondo, come può essere strada valida per ricomporre dentro di noi e nei rapporti sociali vie di concordia e di pace?
Difronte alla guerra in atto, mi sembra attuale richiamare l’implorante domanda di papa Ratzinger in visita nel 2006 al campo di sterminio di Auschwitz: “Perché, Signore, hai taciuto? Perché hai potuto tollerare tutto questo?”. Grido rivolto a Dio, come quello stesso di Gesù in Croce rivolto al Padre: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”: grido assoluto che riassume in sé tutti quelli di un’umanità attonita, inerme di fronte al dolore, al tradimento, alla distruzione. Perché? Partirei da questa profonda, inesauribile domanda di senso per una più matura consapevolezza della nostra fragilità umana, che se da una parte ci può annichilire e disorientare dall’altra ci richiama ad una Realtà, ad una Presenza tra noi, ad un Padre a cui affidarci e con cui camminare insieme per Qualcosa di più grande, per un Ideale di Vita buona per la quale vale la pena vivere e sacrificarsi. Mi è sempre rimasto impresso il versetto del profeta Geremia, riferito a Dio che gli dice: “Prima ancora di formarti, nel ventre di tua madre, prima ancora che tu nascessi, io già ti conoscevo”. Come recita anche un’antica invocazione buddista-zen: “Signore, fa che io veda il mio volto, così com’ero prima che io nascessi”. Dall’Eternità Dio vedeva il mio volto, il mio “dover essere”. Bisogna coltivarlo questo sogno di bellezza che portiamo “dentro”! E saperlo abitare e ritornarci per incontrarlo più volte. E parlare più spesso tra noi di questa casa interiore. Ma per parlarne bisogna prima entrarci. Ed è da qui che il cuore si apre al dialogo sincero tra la realtà che vedo di me stesso e la mia anima, tra quello che sono e il sogno di Dio, accettando che “altro da me” mi abiti, che un Altro entri dentro e mi parli, un Maestro tra noi, con il suo dolce ma esigente invito: “Seguimi”. Un incontro a cui mi posso abbandonare, fiducioso come un figlio. Un cammino, che perfino a Renato Zero ha fatto dire: “In tutte le promesse disattese perdevo me e ritrovavo Dio. È lì la verità, ora lo so”. Di fronte alla guerra, alle molte guerre che combatto dentro di me ogni giorno, alla guerra che corre là fuori, non voglio rinunciare a questo incontro. Ritroverò me stesso e vi fioriranno tante vie di pace.
Michele De Beni – Pedagogista-psicoterapeuta
Esperto in Processi formativi, già Professore di Docimologia e di Pedagogia all’Università di Verona, professore di Programmazione e Valutazione dei processi formativi, Istituto Universitario Sophia, Loppiano (FI).