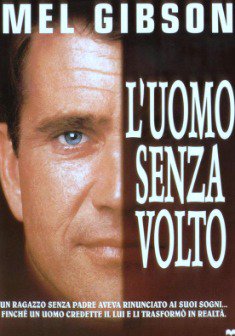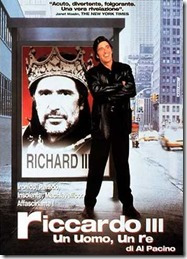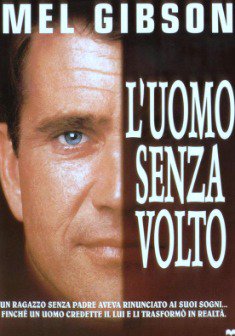
Apr 29, 2021 | Newsletter, Spazio cinema
Paese: USA – Durata: 114 minuti – Regia: Mel Gibson
Recensione
Un ragazzino sogna di essere celebrato come eroe dall’accademia militare e dai membri della sua famiglia, il suo punto di riferimento è John Wayne, ma il suo bisogno più grande è quello di colmare il vuoto di una figura paterna assente.
Tra il 12enne Chuck Norstadt e l’insegnante Justin McLeod (Mel Gibson) nasce un legame di amicizia che per entrambi costituisce la trama di un percorso di crescita personale; Chuck cerca un padre/guida per fuggire la mediocrità di un contesto familiare in cui non riesce a trovare un suo spazio, Justin, rimasto sfigurato dopo un grave incidente, prova ad autopunirsi rifugiandosi in una vita solitaria fatta di musica, scultura, pittura e poesia.
L’uomo senza volto rivela quasi subito la natura ambivalente di un ‘eroe’ diviso tra zone oscure e obblighi morali; natura che si rispecchia in un viso per metà perfetto e per metà devastato dalle cicatrici di gravissime ustioni e rimanda al personaggio Due Facce della serie di fumetti Batman.
L’arrivo di Charles porta una ventata d’aria fresca nella vita tormentata del professore; con lui può tornare ad insegnare, ma non solo: torna a parlare, a sorridere, a scherzare, a confortare… ad amare; nonostante il pregiudizio delle persone che li circondano che non riescono ad andare oltre l’apparire e non colgono la bellezza che traspare dalla relazione tra il professore e il ragazzo. La colpa di cui il professor Mc Leod viene accusato è quella di amare il suo alunno, di amarlo come un vero padre, come quel padre che Charles non ha mai avuto accanto, di abbracciarlo con l’innocente speranza di un semplice conforto.
Impara o vattene, è il motto un po’ sbrigativo del processo educativo di Justin e Chuck, spinto da un forte desiderio di conoscenza, vince la repulsione iniziale per la deformità corporea e dei modi poco ortodossi del maestro, per progredire in un percorso di conoscenza, ma soprattutto di scoperta di sé. Il filo conduttore della loro relazione è l’impostazione di un educazione “al maschile” l’incentivo a cogliere la sfida e la necessità di porsi sempre obiettivi ambiziosi. Chuck proclama la sua voglia di cambiare il sistema e il desiderio di staccarsi in volo da terra per vedere le cose dalla giusta prospettiva (bellissima la scena del volo con il piccolo aeroplano sospeso sopra le acque dell’Atlantico).
In una società bigotta che finge di essere rivoluzionaria per poi fermarsi alla superficie della verità e osservare solo una parte del volto, l’amicizia tra Chuck e Justin resiste alla maldicenza e alla illazione e rivela la tristezza di un mondo che, se trasformato in palcoscenico, costringe ognuno a recitare una parte, a discapito della scoperta di sè.
L’uomo senza volto può essere definito un racconto di formazione che esalta il tema dell’amicizia senza mai cadere nel retorico, ma soprattutto fa riscoprire la bellezza dell’insegnamento in cui l’adulto, l’insegnante, affianca e guida il ragazzo nel suo percorso crescita, con il desiderio di portarlo alla scoperta di sé e dei propri talenti.
Il finale riprende i cappelli lanciati in aria del sogno di Chuck nel prologo: oltre il muro di folla, il saluto di Justin, del maestro all’allievo, è un messaggio di incoraggiamento e speranza di chi ha percorso un tratto di strada al suo fianco e ora è pronto a farsi da parte per lasciarlo entrare nell’età adulta.
Francesca Guglielmi

Apr 29, 2021 | Articolo di fondo, Newsletter
In occasione del centenario della morte di Dante, un secolo fa Benedetto Croce scrisse il saggio Poesia e non poesia in Dante, sostenendo che accanto a brani lirici di imponente grandezza (Farinata degli Uberti, il conte Ugolino, Ulisse ecc.) il resto del poema si potesse considerare tessuto connettivo con divagazioni filosofiche e teologiche del tutto obsolete. Il saggio era funzionale alla concezione estetica del Croce, ma non coglieva l’essenza della concezione dantesca. La sua Commedia è una solida architettura di idee che ha operato la sintesi tra la cultura classica e il mondo cristiano.
La struttura presenta un canto di introduzione e tre cantiche di trentatre canti ciascuna racchiusi in rigorosa terza rima. Compaiono centinaia di personaggi che con la loro storia personale soddisfano la fame di conoscenza del poeta e qualche volta vengono incontro al suo desiderio di vendetta. Il poema è una cattedrale di idee, folto di statue, ma senza nascondere la rigorosa architettura gotica sottostante, lo stile architettonico più innovativo rispetto all’antichità classica.
Dante è vissuto nel XIII secolo, per certi aspetti il più glorioso della cultura italiana. Il secolo inizia con san Francesco, un uomo moderno nel senso che somiglia più a noi che agli uomini dell’età classica. È il primo che si accorge del paesaggio, degli animali, della realtà che lo circonda, dove tutte le cose proclamano di non essersi fatte da sé, perché le ha fatte un altro, Dio, che perciò merita ogni attenzione. La notizia più importante è che Dio si è fatto uomo per condurre l’uomo a Dio. Il presepio di Greccio aveva il valore di una testimonianza totale: rievocare il Natale come era avvenuto la prima volta a Nazaret in Palestina.
Il secolo prosegue con san Tommaso d’Aquino, l’intellettuale più rigoroso che viene conquistato dal realismo di Aristotele. In quel momento, specialmente a Parigi, di Aristotele si apprezzava la logica e la filosofia della natura. Tommaso e il suo maestro Alberto Magno sono convinti che la grandezza di Aristotele vada cercata soprattutto nella metafisica e nell’etica in grado di umanizzare gli usi e costumi ereditati dalla società germanica.
Dante crebbe in una Firenze dominata dalla fazione dei Guelfi: Federico II era morto nel 1250 e il figlio Manfredi nel 1266, nel corso della battaglia di Benevento che cancellava la rotta dei Guelfi avvenuta a Montaperti nel 1260, quando fu solamente Farinata degli Uberti a impedire che Firenze venisse rasa al suolo. Il partito dei Guelfi era dominato dall’affarismo più scatenato. Uniche oasi concesse alla cultura erano gli Studia generalia dei Domenicani a Santa Maria Novella e dei Francescani a Santa Croce dove venivano discusse le tesi di san Tommaso d’Aquino e di san Bonaventura mediante lezioni aperte al pubblico e frequentate anche da Dante. Questi apparteneva a una famiglia che possedeva due poderi, ma vantava la presenza di un trisavolo cavaliere, Cacciaguida e perciò in qualche misura aristocratica, perché non amava i “súbiti guadagni” di chi “Marcel diventa ogni villan che parteggiando viene”.
Dante è essenzialmente un autodidatta. Certamente ci furono alcuni soggiorni di studio a Verona nei primi anni dopo l’esilio, dove poté esaminare i codici della biblioteca capitolare e a Bologna, sede della più famosa facoltà di diritto civile. In Firenze, il personaggio più in vista era Guido Cavalcanti che aveva fama di filosofo. Dante sentiva che la sua posizione era tra gli aristocratici, coloro che in guerra andavano a cavallo, mentre in tempo di pace poteva partecipare ai tornei letterari suscitati dall’entusiasmo per il “dolce stil nuovo” che aveva eclissato la fama della scuola poetica siciliana. Il frutto maturo di questa stagione è la Vita nuova, il mirabile libretto in versi e in prosa che fece di Dante il più promettente letterato della città.
Col nuovo secolo, Dante si impegnò anche in politica, ma il suo insuccesso fu completo. Assistette allo scontro delle fazioni interne ai Guelfi, ossia tra Bianchi e Neri, i partiti che facevano capo ai Cerchi e ai Donati. Dante non apparteneva al partito dei Donati che risultarono vincitori. Essi si affrettarono a imbastire un processo per baratteria terminato con la condanna a morte di Dante che per due mesi aveva esercitato la carica di priore. Il poeta si trovava fuori di Firenze e vi rimase per il resto della vita. I fuorusciti Bianchi tentarono per qualche anno di radunare un esercito formato dai feudatari del Casentino, ma senza successo. Dante, deluso dalla politica, decise di “far parte per se stesso”, conquistato da un progetto filosofico. Gli uomini sarebbero sempre rimasti fuorviati se non partecipavano a un convivio di sapienza che li scampasse dall’errore. Iniziò il progetto del Convivio che doveva essere un trattato in lingua volgare composto di quattordici canzoni, ciascuna seguita da commento, più un trattato introduttivo. Dopo quattro canzoni il progetto si interruppe. Si deve supporre che Dante sia rimasto folgorato dal progetto della Commedia, un poema a cui avrebbero posto mano “e cielo e terra” per spiegare a tutti in lingua volgare, ma con l’allettamento del verso, la filosofia di san Tommaso d’Aquino e di san Bonaventura, in grado di ricondurre Chiesa e Impero nel proprio ordine razionale, assicurando agli uomini la pace e la felicità. Sembra che i primi sette canti dell’Inferno siano stati composti intorno al 1304 e i critici ritengono che siano canti tipicamente fiorentini.
Dante scriveva un ottimo latino che impiegò per il De vulgari eloquentia e per il De monarchia, ma non era un umanista alla maniera del Petrarca che cercava la gloria con la poesia latina.
Dante perciò è poeta-filosofo perché si propone di rendere accessibile la conoscenza della filosofia esposta in latino da san Tommaso anche a coloro che non conoscono quella lingua. Gli episodi lirici della Commedia hanno il compito di attirare mediante drammatizzazione l’attenzione del lettore, ma perché accolga la conclusione filosofica e teologica del problema affrontato.
Se chi legge la Commedia fosse serio, al termine della lettura del poema dovrebbe apparire una persona trasformata in radice. Proverebbe ripugnanza di appartenere al gruppo degli ignavi che non scelgono né il bene né il male, finendo come “color che non fur mai vivi”, rifiutati anche dall’Inferno. Inoltre il sapiente lettore saprebbe che nell’Inferno i dannati sono divisi secondo il loro peccato più grave. Si può peccare per debolezza, per malizia o per matta bestialità. Nello stesso girone vengono condannati alla medesima pena coloro che hanno mancato gravemente contro una virtù. Infatti, la virtù è come il culmine tra due bassi avvallamenti occupati dai vizi per eccesso e per difetto. Ad esempio, il coraggio è il culmine tra la codardia di chi teme anche la propria ombra e la temerarietà di chi presume di sé e si espone per spavalderia a pericoli inutili. La pena segna il contrappasso rispetto alla colpa: i golosi che in vita si sono dedicati alla scoperta di sapori sottili e rari, trascurando la sobrietà del cibo e della bevanda, sono condannati a vivere in “grandine grossa, acqua tinta e neve/ per l’aere tenebroso si riversa; / putre la terra che questo riceve” (Inf. VI, 10-12).
Forse è bene capirsi. Da due millenni e mezzo c’è l’accordo, e non solamente in occidente, che un uomo vale per le qualità possedute. Ne esistono quattro –prudenza, giustizia, fortezza, temperanza- che risultano fondamentali perché ogni altra qualità umana si può ascrivere come parte potenziale a una di quelle citate. Tali virtù si acquistano con la costante ripetizione degli atti corrispondenti e si perdono con la loro omissione. Non può essere considerato virtuoso un uomo carente in modo grave anche di una sola delle virtù indicate.
Alasdair McIntyre con un libro divenuto famoso, Dopo la virtù, dimostrò che non esiste una fondazione filosofica della morale più valida di quella presente nell’Etica nicomachea di Aristotele.
Dante è vissuto in una città dilaniata dai contrasti tra partiti guidati da famiglie rivali, ha assistito all’incendio delle case dei nemici politici, alla loro cacciata in esilio, ai loro tentativi di rientrare alla testa di un esercito che a sua volta avrebbe cacciato dalla città i perdenti di oggi. In termini monetari si potrebbe affermare che le spese di guerra, notoriamente improduttive, erano infinitamente superiori ai profitti che si potevano sperare e perciò risultava spaventosa la condizione della Romagna “che non è mai sanza guerra nel cuor dei suoi tiranni”. La geografia dell’Inferno, con la presentazione icastica dei dannati sottoposti alla legge del contrappasso diventa la più splendida dimostrazione della verità della filosofia di san Tommaso d’Aquino, divenuto il più grande interprete di Aristotele.
Il Purgatorio è un’esigenza di ragione: se in Paradiso si entra solamente quando i conti con la giustizia sono stati pareggiati, occorre il soggiorno in un luogo di purificazione che renda ciascuno “puro e disposto a salire alle stelle”. I personaggi qui incontrati da Dante e Virgilio rivelano il rimpianto del tempo perduto per non aver aderito a un programma razionale di vita. Ora si trovano a dover ascendere la montagna dalle sette balze, ossia la purificazione dalle scorie del peccato. Incantevole l’episodio di Casella il cui amoroso canto fa dimenticare per un poco alle anime di “ire a farsi belle”, sollecitate dal rimprovero di Catone: “Che è ciò, spiriti lenti?/ qual negligenza, quale stare è questo?/ Correte al monte a spogliarvi lo scoglio/ ch’esser non lascia a voi Dio manifesto/: nel corso della vita terrena solamente l’arte è in grado di consolare e riempire la vita di un uomo.
Virgilio conduce Dante fino al culmine della montagna, metafora della ragione che conduce ogni uomo ad ammettere la possibilità dell’esistenza di Dio. Dante con ogni probabilità poté riflettere sull’affermazione di san Tommaso d’Aquino che non si deve credere per fede ciò che si può comprendere facendo uso della ragione. Esiste perciò la teologia che è lo sforzo della ragione umana per introdursi nel mistero divino reso manifesto dalla fede, che a sua volta risulta dalla piena adesione dell’uomo alla rivelazione divina. Dante perciò affronta il giudizio circa le tre virtù teologali di fede, speranza e carità. Superato l’esame può entrare nel Paradiso e salire fino all’Empireo passando attraverso il cielo della Luna, di Mercurio, di Venere, del Sole, di Marte, di Giove e di Saturno. Infine, preceduto dalla supplica di san Bernardo di Chiaravalle alla Vergine, viene ammesso all’ultima visione, a contemplare il mistero della Trinità.
La grandezza di Dante filosofo e d’aver rispettato i campi di competenza altrui: egli considera come il suo peggior nemico Bonifacio VIII, ma ne contesta solamente le scelte politiche che non condivide, senza rifiutare la religione del papa inventandone una nuova. Quando Enrico VII accenna a rivendicare i diritti del Sacro Romano Impero, Dante si pone immediatamente al suo seguito indicando quali sono i diritti dell’Impero. L’Imperatore ha ricevuto direttamente da Dio il potere e deve provvedere al bene della pace superiore ad ogni altro per la vita dei cittadini. Papa e Imperatore hanno il compito di assicurare a ciascun uomo, il primo la vita eterna e il secondo la felicità sulla terra. Perciò Papa e Imperatore devono collaborare, essendo ciascuno autonomo nel proprio ambito di competenza. Nella realtà le cose andarono diversamente. Enrico VII venne in Italia, alcuni comuni lo rifiutarono, il papa si trovava ad Avignone e non andò a Roma per l’incoronazione, mentre vi andò Roberto d’Angiò re di Napoli per impedire ad Enrico VII di rafforzarsi in Italia. Infine l’imperatore morì nei pressi di Siena lasciando ogni cosa più confusa di prima. Dante perdette definitivamente la possibilità di ritornare a Firenze, dovette “salire e scendere per l’altrui scale” imparando “quanto sa di sale il pane” così ottenuto. Trovò rifugio presso Can Grande della Scala a Verona e da ultimo a Ravenna, presso Guido Novello da Polenta, dove concluse la redazione del Paradiso.
Prof. Alberto Torresani

Apr 29, 2021 | Newsletter, Rassegna stampa
di Gianluca Zappa (fonte: Il Sussidiario.net – 25.03.2021)
Secondo l’autore, insegnante, l’anniversario dantesco è l’occasione quanto mai opportuna per rileggere Dante, specie in questo periodo di incertezza e angoscia generale. Non lo dobbiamo lasciare sul comodino, ma fare i conti con lui, con la sua parola profetica e coraggiosa.
“I Budda vanno sopra i comodini” cantava Franco Battiato in Magic Shop, un brano del lontano 1979, che era un’entrata a gamba tesa contro la stupidità del consumismo arrembante. All’epoca, figuriamoci oggi! Il Budda che stavolta corre il rischio di finire sul comodino si chiama Dante Alighieri. Veramente è già finito sui meme, sui social, negli spot pubblicitari, nei biglietti di auguri, nei messaggini che accompagnano i cioccolatini… Cosa non si fa e non si farà in questo 2021, settecentesimo anniversario della sua morte! C’è una ditta di abbigliamento che propone una maglietta per adolescenti con la stampa, in bella evidenza, di una frase che Dante non ha mai detto. Riguarda la fama umana, ma è una parafrasi, anzi, magari lo fosse: è un riassunto di quello che Dante scrive nel canto XI del Purgatorio! Se un verso ha da finire su una maglietta, che sia per lo meno un vero verso! Niente da fare.
Del resto il genio di Dante ha prodotto un’opera densa di tanti endecasillabi folgoranti (che dicono un paesaggio, uno stato d’animo, un evento, un’esperienza, un mondo, addirittura un mistero inesprimibile), che è inevitabile saccheggiarla come un ricchissimo serbatoio di immagini. E in fondo è giusto così: i grandi poeti, è noto, sono quelli che dicono la parola che tutti volevano dire, ma che non riuscivano a trovare, sono quelli che riescono a leggerci meglio di quanto noi non siamo capaci. Quindi ben vengano i versi di Dante anche sulle magliette, anzi, sarebbe bello che ognuno indossi la maglietta col verso che ritiene “suo”, quella che più lo descrive, lo conforta, lo aiuta, gli illumina la vita. Ma perché questo accada, bisogna fare i conti, in modo serio, con l’autore e con la sua opera.
In verità a me sembra che Dante sia come una bella donna alla quale nessuno, o pochissimi, proprio per la sua straordinaria grande bellezza, osano avvicinarsi. Oppure come un tesoro prezioso riconosciuto da tutti, noto a tutti, sulla bocca di tutti, per ottenere il quale nessuno vuole impegnarsi ad usare la pala. Sì, qualche verso biascicato, più o meno verificato; qualche episodio famoso più o meno conosciuto e pochissimo compreso; qualche terzina recitata a memoria come una filastrocca, un po’ come il “m’illumino d’immenso” di Ungaretti; sì, qualche episodio della sua vita, retaggio dell’istruzione scolastica, un po’ di gossip su quella storia con Beatrice alle spalle di Gemma… Tutta questa fuffa sì, va bene. Ma fare della Divina Commedia quello che può diventare davvero, per tutti, e cioè il libro della vita dentro il quale non si finisce mai di penetrare… questo è un altro paio di maniche. Il Budda sul comodino, appunto.
Il fatto è che Dante e il suo “poema sacro” mettono paura. Là dentro, lo si sa bene, ci sono troppe cose: più di seicento personaggi con le loro storie, spesso tratte dal mito, spesso da un mondo medievale sideralmente lontano da quello contemporaneo; e poi riferimenti dotti ad altri poeti e teologi e filosofi; e allegorie difficili, alcune anche impossibili da decifrare (per cui bisogna mandare a memoria non solo l’allegoria, ma anche tutte le interpretazioni dell’allegoria, entrando in un imbuto senza fine che toglie il respiro); e poi astronomia, e scienze dell’epoca (trivio e quadrivio); e quel volgare che troppo spesso richiede una spiegazione che puoi trovare solo in nota.
Ecco, le note… Se pensi alla Divina Commedia pensi, più che alle terzine di Dante, a tutto l’apparato monumentale che la accompagna e quasi l’invade.
A scuola il testo ci è arrivato così, come un insieme di canti slegati, di personaggi slegati, di frammenti l’uno vicino all’altro, da studiare, da approfondire, da “trattenere” in qualche modo. Le note sostanziavano i nostri incubi. Roba da specialisti, non per l’uomo comune. Buffo destino per un poeta che proprio lì, in quel poema, ha scritto che “non fa scienza sanza lo ritenere avere inteso”.
“Ritenere”… trattenere dentro di sé, in qualche modo rivivere, immedesimarsi, penetrare dentro un’esperienza. Dante ci invita a questo, questo definisce vera scienza, vero conoscere (ciò che tutti gli uomini desiderano). Ci si pone di fronte con tutta la forza della sua visione, con la serietà gioiosa di chi ha davvero visto Dio, e ci chiede di seguirlo nel suo viaggio bello e drammatico dall’esito glorioso. Ci apostrofa, ci scongiura di fare la strada con lui in questo “cammin santo” che si confronta con quelle Colonne d’Ercole (prendo a prestito la bella intuizione di Davide Rondoni che ho sentito parlare la scorsa settimana in una delle lezioni dei Colloqui Fiorentini) che rappresentano il mistero della nostra vita, di ogni istante della nostra vita. La Commedia è divina perché è profondamente umana, nel senso che nasce, vive e chiama in causa l’uomo, tutto l’uomo, ogni uomo.
Ci siamo proprio noi lì dentro, i nostri desideri, le nostre domande, i nostri errori. Gli sviamenti, le insoddisfazioni, i limiti, le paure, ma anche la nostra continua esigenza di perdono e di significato, di verità, di bellezza, di amore. Qualcuno ha detto che il viaggio nell’aldilà è in effetti un viaggio nell’aldiqua. È una bella immagine, ma dobbiamo andare al grande e felice messaggio che Dante ci vuole lasciare: a questo poema (che narra una storia sacra, e che è scritto quindi secondo l’allegoria dei teologi, come la Bibbia) hanno posto mano “e cielo e terra”. La realtà davanti alla quale ci pone Dante è dunque questa: Dio mi ha incontrato, mi ha visitato, mi ha abbracciato! Solo questo, nientemeno che questo. Il Cielo è venuto incontro alla terra e l’ha redenta. È il Natale e la Pasqua insieme. Può bastare o abbiamo bisogno di altro?
Certo, questo annuncio è una sfida, perché è verificabile e reperibile solo dentro un’esperienza. “Expertus potest credere”, cantava la Chiesa con un inno composto, pare, proprio da quel san Bernardo che Dante sceglie come sua ultima guida nell’imminenza di Dio. Ma è una sfida per la vita, non per la morte.
Il centenario di Dante cade in un 2021 quasi dilaniato dalla paura, dall’angoscia, dall’incertezza. Mai come oggi abbiamo bisogno della forza profetica di qualcuno che ci dica che cambiare vita è per il bene. E Dante è questo profeta, un uomo che ha dimostrato, con coraggio e coerenza, di essere uno che dice il vero fino in fondo, che “vede e vuol dirittamente e ama”. Di uno così abbiamo un’autentica, stringente necessità. Dobbiamo smettere di fuggire il suo poema o di girargli intorno smozzicandone qualche bella immagine. Dobbiamo farci i conti. Non merita, non può finire sul comodino!
Gianluca Zappa

Apr 29, 2021 | Articolo di fondo, Newsletter
Nel 2021 ricorre il VII centenario della morte di Dante Alighieri, il sommo Poeta che più di tutti ha “sdoganato” la lingua italiana e ha consegnato ai posteri uno dei più grandi capolavori dell’intelletto umano.
Uomo del suo tempo, pienamente inserito nella realtà sociale, politica e culturale del Medioevo, Dante si è tuttavia fatto interprete delle immortali aspirazioni del cuore e della mente dell’uomo.
Prof. Rizzi, sappiamo che lei utilizza molto – e con grande profitto – la Divina Commedia nelle sue lezioni con alunni della scuola secondaria di I grado. Come riesce ad entusiasmare i ragazzi del III millennio all’opera dantesca, così lontana dai loro riferimenti culturali?
«Nel mezzo del cammin di nostra vita…» sembra un incipit rivolto primariamente a persone già ricche di esperienze e con anni alle spalle, ma Dante voleva essere davvero così “esclusivo” o avrebbe avuto il piacere di sapere che il suo testo interpella e coinvolge anche i più giovani o addirittura i giovanissimi? Effettivamente quest’anno con i ragazzi di una seconda secondaria abbiamo intrapreso il viaggio che Dante ha inaugurato e di cui si propone come guida: per me è stata la prima volta che mi capitava di provare a rendere destinatari della “Divina Commedia” dei ragazzi di dodici anni. Indubbiamente all’inizio dell’anno, durante il periodo delle “fatidiche” programmazioni, avevo qualche dubbio su come potesse essere recepito e accolto questo testo, cioè sulla possibilità per ragazzi della scuola secondaria di primo grado di avere gli strumenti e le capacità per, non solo comprendere, ma anche apprezzare – e magari anche entusiasmarsi – per le terzine più famose della letteratura italiana. L’opportunità e l’efficacia della proposta, mi sono detto, passerà inevitabilmente dalla capacità di intercettare un loro interesse, una loro domanda o semplicemente una loro curiosità. Dante può rappresentare un punto di attrazione per i giovanissimi oppure come i tanti oggetti “culturali” (musei, mostre, conferenze, ecc.) alle loro orecchie il solo nome o la sola proposta produce un immediato calo dell’interesse e un crollo, quasi spontaneo, della loro attenzione? Tanti sono gli elementi che potrebbero scoraggiare quest’occasione che abbiamo scelto di perseguire quest’anno: l’ostacolo linguistico, la non immediatezza di alcuni temi trattati, la difficoltà oggettiva di alcuni contenuti, la lontananza storica, culturale delle vicende narrate, ecc. A ciò si deve aggiungere il fatto che parlare oggi a un ragazzo di seconda media di poesia significa, di fatto, perdere il contatto comunicativo: come iniziare a parlare in un’altra lingua, oscura e incomprensibile, e per giunta di scarso interesse. La poesia – queste sono le percezioni emerse più volte dai ragazzi – è lenta, “faticosa”, noiosa e i poeti sono inutilmente complessi, orgogliosi dei loro giochi di parole e completamente ripiegati su una sorta di sentimentalismo vuoto ed emotivo, un inno soggettivo e melanconico di un malessere di cui, sinceramente, se ne può fare anche a meno. MA – e questo ma vuole richiamare quello che spiega il motivo per cui Dante ha desiderato raccontarci il suo viaggio, forse il “ma” più importante della letteratura italiana: «MA per trattare del ben ch’i vi trovai, / dirò delle altre cose ch’i’ v’ho scorte» – i ragazzi a questa età sono appassionati di storie e sono avidi di esperienze. Storie, insomma, quelle in cui loro sguazzano quotidianamente e in cui sono totalmente immersi: i videogiochi ormai onnipresenti e che potrebbero essere considerati, a dirla grossa, i romanzi della nostra epoca; i social, con le “storie” di Instagram o i video di Youtube. Allora la domanda diventa: la storia di Dante può strappare dagli schermi la loro attenzione e accendere la loro curiosità? Come sempre, infatti, dipende dalle storie che si scelgono di raccontare: a me sembra che Dante abbia scritto “LA” storia che, se ben adattata, non può lasciare indifferenti. Adattamento: utilizziamo un testo in prosa con numerosi riferimenti alle terzine originali e, a volte, concedendoci il piacere di qualche episodio completo dall’”originale”. L’approccio narrativo, le storie dei singoli personaggi, i numerosissimi argomenti che scaturiscono dalla lettura sono gli ami che, una volta lanciati, prendono i ragazzi nella rete delle curiosità, delle domande, di un apprendimento che non nasce da un’imposizione esterna e si traduce solo in un mero accumulo di nozioni, ma una voglia di sapere che mi sembra possa essere considerata il vero obiettivo dello studio della letteratura. In più, aggiungerei il fatto che, sebbene oggettivamente alcuni contenuti siano difficili e distanti dalla loro esperienza quotidiana, il fatto di proporgli un testo “arduo”, di alzare un po’ l’asticella dell’ostacolo da saltare, ha prodotto una sorta di sfida rispetto alla quale i ragazzi di dodici anni – sì, anche quelli “di oggi” – non si sono tirati indietro. Anzi, in conclusione, direi che prenderli sul serio, trattarli da “grandi”, forse è proprio quello che cercano maggiormente e di cui hanno bisogno a questa età.
Quali sono i feedback che riceve dagli alunni durante e dopo le sue lezioni? Mi spiego meglio: riescono i contenuti dell’opera dantesca a “fare breccia” nelle menti e nei cuori dei suoi giovani allievi?
In un tema, nel quale ho chiesto loro di scrivere in merito a quale argomento avesse colto di più la loro attenzione, le “storie” che hanno generato più sorpresa (ma si potrebbe dire anche paura, commozione, ribellione, ecc.) sono state quelle degli Ignavi e quella del Conte Ugolino. Degli Ignavi colpisce come essi, non avendo scelto né il bene né il male, proprio per questo motivo, si trovino «a Dio spiacenti e a’ nemici sui», esclusi anche dall’Inferno. La prima volta che ho letto questo brano a ottobre sono stato letteralmente travolto da domande: moti di indignazione, domande esistenziali (“Non vado a Messa spesso né faccio nulla di male: perciò finirò in questo gruppo?”), considerazioni svariate sul perché e il percome Dante avesse fatto bene/male a creare questo specie di sottogruppo rigettato da tutti e punito in un modo così orribile e repellente. Anche durante il corso dell’anno questo episodio è stato uno di quelli che maggiormente ha “fatto breccia” ed è stato più volte richiamato all’attenzione e alla memoria. Per esempio in occasione del Dantedì a scuola abbiamo proposto alcune letture di Dante e il brano più scelto dai ragazzi è stato proprio questo. Molte altre vicende dell’Inferno hanno “fatto breccia”: Paolo e Francesca, Pier Delle Vigne, Ulisse, il Conte Ugolino e Lucifero. Indubbiamente l’Inferno è quello che ha attirato di più e che ha prodotto maggior curiosità. Ho percepito l’emozione sincera di alcuni ragazzi alla lettura del brano sul Conte Ugolino (un ragazzo è andato a Pisa in quei giorni e mi ha contattato online solo per dirmi che aveva visto la Torre della Fame), ho colto la curiosità di vari alunni nel vedere Dante mettere il suo maestro all’Inferno o nel vedere la forza con cui condanna uomini di Chiesa e alcuni papi. Seguire le storie dei personaggi, permettere loro di raccontarle e di riscriverle, chiedere la loro opinione: tutte modalità didattiche che sono servite a coinvolgerli e a mantenere vivo il contatto con il testo. Tre esempi concreti che hanno permesso di mantenere accesa la loro attenzione nel corso della lettura; potremmo intitolarli: “Trova la legge del contrappasso”, “Improvvisati un nuovo Dante”, “Leggi, rileggi e…impara a memoria”. La curiosità di vedere le pene dei dannati ha portato la stragrande maggioranza della classe a procedere in autonomia nella lettura per vedere la pena successiva: più di metà della classe aveva concluso la lettura dell’Inferno quando ancora in classe stavamo commentando le Malebolge. Scoprire la pena, saper spiegare il contrappasso, conoscere la struttura dell’Inferno (mi sono servito anche di qualche tavola e di qualche video), spiegare i diversi tipi di peccati, la loro tipologia e le loro caratteristiche, il “protagonista” di questo o di quell’episodio, sono stati gli elementi che hanno catturato la loro curiosità. Mi sono divertito molto nel leggere alcuni temi che gli ho assegnato in cui dovevano, per esempio, raccontare un certo episodio immedesimandosi in un personaggio dantesco oppure inventare una nuova pena per una categoria di peccatori contemporanea che a loro parere Dante avrebbe inserito nella Commedia se l’avesse scritta oggi. Vederli scrivere dei testi, tentando di mantenere il sapore dantesco, catalogando come traditori i cyber-bulli, condannando le slealtà quali le mormorazioni, le prese in giro o denunciando il razzismo…mi sembrano esempi significativi di come, sul modello di Dante, si possa prendere posizione rispetto ad alcuni comportamenti, la cui maggior consapevolezza li potrà aiutare nel mantenersene a distanza. Poi certo c’è stato anche chi si è divertito a descrivere le pene più crudeli per chi non studia o per coloro che non tifano una certa squadra, ma questo fa parte del gioco. Ho trovato molto utile, e mi sembra sia stato apprezzato, anche il fatto di imparare alcuni brani a memoria per poi recitarli: l’iscrizione sulla porta dell’Inferno, il discorso di Ulisse, la preghiera di san Bernardo…o addirittura un intero canto! Ho lanciato quest’ultima sfida durante la prima lezione e so che c’è qualcuno tra gli studenti che ci sta provando…vedremo nel prossimo mese
Quale reazione suscita l’aldilà in ragazzi abituati a una visione tutt’altro che trascendente, immersi costantemente nel presente?
Mi viene in mente una barzelletta in cui la maestra chiese alla classe chi tra gli studenti volesse andare all’Inferno: tutti gli alunni impauriti e timorosi rimasero al loro posto senza fiatare né alzarono la mano. Allora la maestra riprese: «Chi vuole andare in Paradiso?». Tutti nella classe risposero in fretta sbracciandosi e urlando uno sopra l’altro: «Io, io!». Solo Pierino non aveva mosso ciglio e non aveva alzato la mano a nessuna delle votazioni. La maestra preoccupata gli chiese: «Pierino, tu non vuoi andare in Paradiso?» e Pierino le rispose: «Per la verità, per ora, sto bene anche qua!» I ragazzi, nonostante le apparenze, pensano molto all’aldilà, e mi sembra che vadano presi sul serio, senza storielle o favolette che non accontentano più, non bastano alla loro età. Cercano spiegazioni, chiedono perché, vogliono, e a volte esigono, da genitori e professori o educatori in genere, la verità. Molti durante quest’età hanno già conosciuto la morte o la sofferenza perché magari hanno perso qualche persona cara: i nonni, una zia, il vicino di casa o un conoscente di famiglia per qualche incidente. Credo sia doveroso provare ad aiutarli a darsi delle risposte, sapendo che le domande sulla morte o sulle realtà ultime già le coltivano in modo vivo e personale. Credo che la Divina Commedia li possa aiutare a formarsi un pensiero, a riflettere sul bene e sul male, a mettersi in discussione: il contrario dell’amore non è l’odio, ma l’indifferenza. Ecco credo che Dante aiuti a non rimanere indifferente, a porsi domande, a non accontentarsi. Il problema della mancanza di trascendenza non è dentro gli alunni, ma è fuori di loro ed è così invadente questa sorta di appiattimento sull’oggi, sul possesso, sul “mio”, che penso che Dante possa solo essere un’occasione in più per ciascuno per alzare lo sguardo e gustarsi un po’ il panorama e cercare l’orizzonte. Viva Dante se riesce davvero a scuotere un po’ le rassicuranti, quanto ingannevoli, certezze della comodità e di un certo clima consumistico e egocentrico! Viva Dante se riesce a restituire un poco di interiorità e di capacità critica e di riflessione! Viva Dante se si generano discussioni e nascono occasioni di confronto su che cos’è il bene e che cos’è il male, su chi è l’uomo e chi è Dio. Direi che Dante può stimolare ad avere prospettiva, e non solo in una dimensione di fede, anzi direi che prima ancora incoraggia una riflessione a partire semplicemente da chi è l’uomo, da quali siano i suoi desideri e come questi si possano configurare in un orizzonte ampio di senso. I ragazzi di dodici anni frequentemente sono abituati a stare in superficie (spesso è la superficie di qualche schermo che diventa un filtro che può separarli o allontanarli irrimediabilmente dalla realtà stessa) e non sono abituati a scendere in profondità e a coltivare uno spirito riflessivo, tanto da diventare assuefatti o anestetizzati rispetto a ciò che li circonda. Sembrano indifferenti (solo sembrano!), ma bussando al cuore con la potenza del racconto di Dante credo che naturalmente si sentano scossi, messi in discussione, e diventino perciò attivi e partecipi: durante le lezioni molte volte, senza che io lo stimolassi, proiettavano ciò che leggevano sulla loro vita e molte volte sono venute fuori domande più esistenziali e cariche di significato. Direi che Dante incoraggia a guardarsi dentro e ciò è utile ad ogni età, particolarmente efficace in un’età in cui i ragazzi strutturano i primi “esperimenti” di pensiero critico e iniziano a prendere decisioni in autonomia.
Nella recente lettera apostolica Candor lucis aeternae, papa Francesco parla della vita di Dante come “paradigma della condizione umana”. È d’accordo con questa affermazione?
Intanto mi ha fatto molto piacere costatare che anche Papa Francesco abbia dedicato attenzione all’anniversario dantesco. Sono convinto che lo stile “pastorale” di questo pontefice abbia intravisto in Dante un elemento di dialogo, un terreno fertile di semina e di confronto con l’uomo di oggi. Se è vero che la letteratura fa vivere le grandi storie in quanto esse sono espressione e simbolo dell’aspetto più profondo dell’umanità (e proprio perciò esse hanno la capacità di interrogare l’uomo di ogni epoca), allora credo che il Papa abbia desiderato, non solo unirsi ai cori di omaggio al Sommo Poeta, ma anche cogliere l’opportunità per incoraggiare l’uomo di oggi alla speranza cristiana. Lasciar parlare Dante attraverso la bellezza dei versi della Commedia perché essa “attrae” – un’altra parola chiave per Papa Francesco – e offre, allo stesso tempo, un cammino e una luce di speranza. Per dirla con Dostoevskij: «Lo conoscevi questo segreto? Ciò che fa paura è che la bellezza non sia soltanto spaventosa ma anche misteriosa. Qui il diavolo combatte con Dio e il campo di battaglia è il cuore dell’uomo». La bellezza, anelata e cercata da ogni uomo, – come il bene e il buono – spalanca le porte alla gioia ed è Dante stesso a confermarcelo, quando ormai arrivato alla fine del suo viaggio nell’Aldilà, nella festosità della rosa dei beati, intravede la Madonna e La descrive con parole semplicissime ma dense di significato: «Vidi ridere una bellezza». Per me questa è la sintesi più potente per raffigurarci il Paradiso, l’esito finale del viaggio «da l’infima lacuna de l’universo» alla visione stessa di Dio, a cui Dante ci stimola a guardare e a cui il Papa ci incoraggia a fare affidamento con fiducia. “Siamo nati e non moriremo mai più”, è uno degli appunti di Chiara Corbella Petrillo, una giovane madre e sposa prossima alla beatificazione (consiglio la lettura della commovente biografia): è un’altra testimonianza forte e audace di chi ha già percorso questo cammino.
Daniele Marazzina
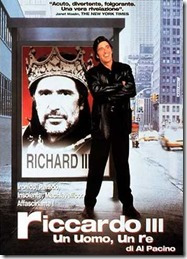
Mar 25, 2021 | Newsletter, Senza categoria, Spazio cinema
Paese: Stati Uniti 1996 – Durata 109 minuti – Regia: Al Pacino
Metà film, metà documentario, Riccardo III – Un uomo, un re (titolo originale Looking for Richard) è anche e soprattutto un omaggio di Al Pacino al teatro e in particolare a Shakespeare.
Egli, che è sia regista che protagonista, con attori amici simula una compagnia che deve mettere in scena il Riccardo III offrendo allo spettatore il resoconto delle prove sia in abiti normali sia in costume alternate a discussioni accalorate sul modo giusto di recitare i testi del grande drammaturgo (compreso un divertente accenno al pentametro giambico, il verso usato nella grande poesia inglese). Arricchiscono il tutto interviste a celebri interpreti shakesperiani e a studiosi universitari come pure visite ai luoghi significativi come la casa natale del bardo o al sito londinese dove sorgeva il Globe Theater.
Come ammette lo stesso regista, il suo sogno è trasmettere agli altri i sentimenti di Shakespeare, nonostante che il linguaggio usato, e le stesse trame dei testi, appaiano alla persona comune lontano e complicati, come emerge da alcune delle risposte date da passanti intervistati. Ma non tutte le persone comuni fermate per strada trovano Shakespeare noioso: la giusta grandezza del suo teatro viene colta da chi dice che “più che aiutare, Shakespeare istruisce”; oppure che egli “dà sentimenti”, e per questo “andrebbe insegnato nelle scuole”. Un altro ancora dice che “quando si sente quello che si dice”, le parole usate, anche se desuete, “hanno un significato più forte”, quasi a replicare a chi trova il linguaggio del bardo inglese irrimediabilmente distante e superato.
La passione di Pacino per l’opera Riccardo III, oltre alla sua indiscutibile bravura, è tale che a mano a mano che passa il tempo si riesce a entrare nella psicologia perversa e luciferina del personaggio oltre a conoscere l’ambientazione storica della tragedia. Figura realmente esistita, egli visse durante la Guerra delle due rose tra York e Lancaster. Riccardo, duca di Gloucester e fratello del re Edoardo malato e prossimo alla morte, è roso dall’ambizione di succedergli, anche a motivo della frustrazione patita a causa di una deformità fisica. Privo di scrupoli pur di conquistare il potere, tesse una fitta trama di congiure per eliminare i possibili rivali alla successione al trono. Ma la storia termina con la sua sconfitta per opera di Enrico Tudor, che lo ucciderà sul campo di battaglia di Bosworth Field ponendo così fine alla guerra civile che per trent’anni aveva insanguinato l’Inghilterra.
È al termine della storia che si trova la battuta più celebre del dramma, quando il re si trova appiedato, incapace quindi di allontanarsi dalla morte certa per mano dei nemici, e con un grido disperato esclama: “Un cavallo, un cavallo, il mio regno per un cavallo!”.In conclusione, la scommessa di fondo di Looking for Richard è quella di dimostrare che la grandezza di Shakespeare (ma la cosa si potrebbe dire di ogni classico del teatro) oggi e sempre sta nell’insegnarci a conoscere l’animo umano nelle sue pieghe più intime, non con un discorso astratto, ma attraverso i sentimenti che la voce e il corpo degli attori sanno suscitare: pathei mathos, cioè “imparare attraverso la passione”, avrebbe detto il grande tragediografo greco Eschilo. E del resto è lo stesso Pacino ad avere detto che “Io credo che si reciti solo nella vita, mentre nell’arte si persegue solo la verità”.
Alessandro Cortese

Mar 25, 2021 | Newsletter, Rassegna stampa
di Fabio Gervasio (fonte: Orizzontescuola.it – 23.03.21)
La didattica a distanza sta provocando un grande cambiamento nella scuola a causa dell’uso sempre più pervasivo delle nuove tecnologie. Nell’intervista padre Paolo Benanti, francescano, individua le caratteristiche e i rischi insiti in queste innovazioni, sollevando le questioni etiche implicate dal progresso tecnologico nel campo della comunicazione e dell’informazione.
Tecnologia e didattica: la scuola serve ancora? Verso un’apocalisse? Risponde Padre Paolo Benanti, esperto di Teologia morale e bioetica
Padre Benanti, la crisi pandemica ha costretto il mondo della scuola a ricorrere massicciamente alla tecnologia mediante la didattica a distanza. La DAD è stata fondamentale durante il primo lockdown, oggi sono molti i dubbi in merito al suo utilizzo. Prima della pandemia abbiamo avuto approcci contrastanti nei suoi confronti passando da quello aperto, come nel caso del BYOD (Bring Your Own Device), a quello di totale chiusura, ad esempio vietando l’utilizzo di dispositivi in classe. Parafrasando Umberto Eco, secondo lei dobbiamo avere una visione apocalittica o integrata rispetto all’uso della tecnologia a scuola?
Per rispondere a questa domanda parto da un articolo di recente pubblicazione, febbraio 2021, apparso sulla rivista scientifica “Cyberpsychology, Behavior and Social Networking” e intitolato “Surviving Covid-19: the Neuroscience of Smart Working and Distance Learning”. È un articolo frutto del lavoro di uno studioso italiano, Giuseppe Riva, e di altri studiosi come Brenda Wiederhold e Fabrizio Mantovani, nel quale viene riportato il risultato delle loro ricerche che si sono concentrate sull’osservazione di cosa accade in persone sottoposte ad un processo continuato di apprendimento a distanza e di smart working. Partendo dal risultato del loro studio, e rimanendo sull’aspetto legato al distance learning, possiamo affermare che l’impatto su alcune fasi cognitive del cervello è un impatto particolare.
Per capirci meglio, quando l’apprendimento accade in un ambiente fisico dedicato, all’interno del nostro cervello si attivano dei neuroni che hanno una sorta di funzione GPS e che ci localizzano all’interno di quell’ambiente attivando una forma di memoria che è di tipo autobiografica. Tutto questo avviene all’interno di un ambiente la cui caratteristica è di avere una consistenza tridimensionale. Quando invece l’apprendimento viene surrogato da una tecnologia, la cui caratteristica è di essere di tipo bidimensionale perché ci vediamo attraverso uno schermo, si sperimentano delle sensazioni di disorientamento, ci si sente come di stare senza un posto e proviamo il disabbandono di un luogo, la classe, e questo aspetto bidimensionale produce, inoltre, una riduzione dell’identità professionale e sociale, provocando anche un po’ di Burn Out. È evidente, alla luce di quanto finora osservato, che lo strumento non è neutrale, inoltre è importante ricordare che nella fase dell’apprendimento hanno un ruolo di primo piano i neuroni a specchio, che, in una didattica mediata dallo schermo, non si attivano in maniera adeguata e riducono il senso di leadership nei confronti di chi ci sta parlando. In aggiunta possiamo riscontrare delle oscillazioni intercerebrali che cambiano il modo con cui si realizza una sorta di coinvolgimento con le restanti parti della classe. Quindi se dovessimo chiederci se la Didattica a Distanza possa essere equiparata alla didattica in presenza, alla luce delle ricerche neuroscientifiche la risposta è chiaramente no. Ma la domanda che lei mi ha posto non è semplicemente di carattere funzionale, è anche di carattere etico e quindi dovremmo chiederci anche “come reagire a tutto questo”.
Qui si apre la seconda questione, è chiaro che l’etica è sempre una scelta del bene possibile, allora se dovessimo scegliere tra nulla e la DAD è senz’altro meglio la DAD. Precedentemente abbiamo affermato che la DAD non è equivalente alla didattica in presenza, ma trovare un bilanciamento tra presenza e DAD è un aspetto sul quale dobbiamo affidarci a quelle che sono le migliori conoscenze scientifiche di coloro che stanno cercando di gestire la pandemia, in modo tale che ci possano dire quale sia veramente il momento necessario per sospendere la scuola in presenza per poi passare alla DAD. Senz’altro l’epoca che abbiamo vissuto ci ha fatto vedere che possiamo digitalizzare dei processi, il tempo esteso con cui abbiamo fatto vivere ai nostri ragazzi questi processi ci dicono che non è uguale il processo digitale dal processo fisico. Non è nullo, ma è meno efficace del processo fisico. La scuola ancora serve, allora non si tratta di essere apocalittici o integrati, ma di essere, se volete, etici, cioè di scegliere il massimo possibile per il bene dei ragazzi che abbiamo davanti.
La tecnologia ci sta portando verso un cambio epocale. Lei più volte ha ricordato che già in passato, nel XVI secolo, un altro artefatto tecnologico, la lente convessa, ha prodotto un cambio epocale. Cosa ha comportato il cambiamento in quel periodo e cosa ci dobbiamo aspettare oggi.
Quello che ha apportato la scoperta della lente convessa, con la realizzazione del telescopio e del microscopio, è stato un cambiamento sul come noi studiavamo e capivamo il cosmo e di come studiavamo e capivamo l’uomo. Abbiamo scoperto di non essere il centro dell’universo e abbiamo scoperto di essere fatti di piccole parti viventi che chiamiamo cellule. Entrambe queste cose hanno cambiato i nostri punti di riferimento.
Oggi un cambiamento analogo avviene ad opera del computer che lavora i dati, che non ci permette di studiare l’infinitamente grande o l’infinitamente piccolo, ma l’infinitamente complesso delle relazioni che accadono. Questo approccio sta nuovamente cambiando il modo con cui studiamo il cosmo, si pensi al fatto che ascoltiamo i dati che sono sostanzialmente raccolti dai radiotelescopi nello spazio, e allo stesso tempo ascoltiamo l’attivazione neuronale di tutte quelle cellule che di fatto sono all’interno del nostro cervello. Questo cambiamento sta producendo una trasformazione il cui esito non ci è ancora noto, non siamo in grado di vederlo, ma è una trasformazione epocale che in alcuni miei testi ho chiamato Digital Age, o più semplicemente cambio d’epoca.
Cosa ci dobbiamo aspettare? Ci dobbiamo aspettare un cambiamento anche nel nostro modo di passare le competenze ai giovani, perché se cambiano i punti di riferimento, come è cambiato il curriculum scolastico, o il modo in insegnare nel passaggio dalla cultura classica alla cultura scientifica, probabilmente dovrà cambiare qualcosa anche in questa situazione.
La crescita esponenziale della tecnologia ha portato ad una interazione sempre più profonda con l’uomo. In una società liquida, come la definisce Bauman, la disponibilità di grandi volumi di dati, i Big Data, permette la realizzazione di Intelligenze Artificiali sempre più efficienti al punto di condizionarci nelle nostre scelte, lei ci parla di Algocrazia. Questo aspetto ha aperto una riflessione sull’uso corretto della tecnologia, della necessità di un’etica nella tecnologia, l’Algoretica. Ci spiega questi aspetti?
C’è uno studioso statunitense, Langdon Winner, che per spiegare cos’è l’etica della tecnologia chiedeva di osservare i ponti che sono stati realizzati sull’autostrada che da New York porta fino alla spiaggia, Long Island. Ecco, chi guarda i ponti vede solo dei ponti, se però noi scavassimo un pochino più a fondo noteremmo che i ponti sono stati costruiti un po’ più bassi rispetto all’altezza degli autobus, questo per consentire solo alle macchine di poter arrivare alla spiaggia e all’epoca in cui sono stati costruiti, ad opera di Robert Moses, è stata un’azione volontaria fatta per impedire a chi non possedeva una macchina, quindi alle fasce più povere e alle minoranze, di poter raggiungere la spiaggia. Nel suo ragionamento Langdon Winner arriva alla conclusione che ogni artefatto tecnologico è una disposizione di potere.
Oggi la questione non riguarda più la costruzione di ponti in calcestruzzo, ma di algoritmi che ci permettono di entrare o ci tengono fuori dalle basi dei dati, che ci permettono o non ci permettono di fare alcune cose, come ad esempio di volare, di ottenere un prestito, o che in alcuni casi vorrebbero di fatto gestire anche la giustizia. È evidente che il potere non è più in calcestruzzo ma è algoritmico, da qui il termine algocrazia. Cosa è chiamata a fare l’etica della tecnologia? Ad essere quella voce che domanda qual è il senso del bene e che cosa stiamo realizzando. È un nuovo capitolo dell’etica che cerca di rendere computabile agli algoritmi alcuni principi che animano la scelta del bene. Questo nuovo capitolo dell’etica, all’interno di questo viaggio, deve rendere visibili ed efficaci queste istanze, come fossero dei grandi guardrail digitali all’interno di questo mondo sempre più automatizzato.
Gli algoritmi ci condizionano nelle nostre ricerche. In ragazzi in fase di formazione cosa comporta questo aspetto legato all’algoritmo che ci permette di vedere solo alcune delle scelte possibili.
È chiaro che stiamo parlando di algoritmi, tante volte di intelligenze artificiali, che animano le piattaforme sociali. Possiamo pensare agli algoritmi come l’ermo colle di Leopardi, solo che sono meno poetici dell’ermo colle ed escludono lo sguardo su alcune cose e ci fanno focalizzare su altre. Gli studi che si stanno realizzando ci dicono che questi algoritmi sono in grado di creare una sorta di bolla intorno a noi nella quale vediamo sempre lo stesso tipo di notizie ripetute più volte. Questa bolla di ripetizioni plurali, di fatto crea una sorta di filtro sulla realtà e un ragazzo che è nel pieno sviluppo della crescita, che dovrebbe guardare con gli occhi limpidi dello stupore e della meraviglia, potrebbe in qualche modo essere condizionato, essere “educato”, non da un mentore, non da un Socrate, non da qualcuno che vuole il suo bene, ma da uno strumento che ha come unica finalità quello di tenerlo il più possibile su quella piattaforma perché chi la possiede in questo modo guadagna più soldi. Tutto questo è un qualcosa che ci chiede di agire, perché stiamo creando la prima generazione che utilizza il telefonino in maniera indistinta tra adulti e ragazzi. Cosa voglio dire con questo, facciamo un esempio, quando il segno del crescere era il motorino, il motorino non era una motocicletta, era adatto ai ragazzi. Oggi, invece, lo stesso strumento, il telefonino, è identico per un adulto o per un ragazzo. Questo ci porta a riflettere sui cambiamenti necessari per adeguare gli strumenti in base a coloro che saranno gli utilizzatori finali.
Nei suoi interventi l’abbiamo sentita spesso parlare dell’Oracolo di Delfi affiancandolo al nome di una delle più importanti società di database “Oracle”, oracolo, come se avessero in comune degli aspetti ben specifici. Ci spiega questo paragone?
È un gioco di parole. C’è un frammento di Eraclito, uno dei padri della filosofia, che dice che l’oracolo che è in Delfi non parla e non tace ma significa. Oggi quando noi interroghiamo un motore di ricerca esso non parla e non tace ma significa dei dati in base alla nostra ricerca. Quindi io uso questo gioco di parole per dire che tanti nostri contemporanei iniziano ad avere nei confronti del computer, soprattutto del computer che lavoro in internet, che lavora i dati, una sorta di accesso oracolare, come se fosse una specie di divinità, che dà delle sentenze, che dà delle risposte alla loro ricerca, al loro destino, al loro futuro. E questo accade quando lo utilizziamo per cercare, ad esempio, cose importantissime come l’anima gemella.
Anche il mondo della scuola sta vivendo un cambio epocale dove la conoscenza non è più esclusiva dei docenti. Molti ragazzi, definiti per semplicità come nativi digitali, sono più capaci nell’uso delle tecnologie rispetto ai propri insegnanti, gli immigrati digitali. Cosa comporta questo cambio di paradigma e quanto è importante pensare ad un’istruzione che porti ad un’alfabetizzazione digitale.
È fondamentale perché oggi assistiamo ad una nuova forma di analfabetismo. Se nel medioevo l’analfabetismo era entrare in una biblioteca e non saper leggere quello che c’era sui volumi, oggi un analfabetismo digitale lo potremmo definire come l’essere immersi all’interno di un flusso di dati, di parole, di video o di audio, e non sapere riconoscere cos’è la verità e cosa non lo è. Questa nuova forma di analfabetismo digitale può provocare qualcosa di simile a quello che ha provocato per analogia il vero analfabetismo, e cioè la dipendenza di chi non è alfabetizzato da chi invece è alfabetizzato. Questo può causare, di fatto, la cessazione di quella funzione sociale di integrazione, di sviluppo della persona, che è compito della scuola. Allora quella che noi chiamiamo alfabetizzazione digitale altro non è che una serie di strumenti che dobbiamo sviluppare e affinare per permettere alla scuola di svolgere pienamente il suo ruolo educativo, e non solo formativo, per questa generazione di nativi digitali.
Il Professor Floridi asserisce che siamo passati ad un uso tecnologico che dall’online è passato all’onlife, perennemente connessi. La società muta rapidamente con ripercussioni anche sul mondo della scuola. I ragazzi al termine del loro ciclo di studi si troveranno di fronte a lavori inesistenti al momento in cui hanno iniziato questo ciclo. La scuola, quindi, non deve formare persone in base alla società esistente, ma deve dare gli strumenti per poter affrontare le sfide future. Da qualche anno è stato introdotto il Coding nella scuola, è la strada giusta?
Questo è un dibattito molto ampio a livello internazionale. In pratica parte dalla domanda precedente, ci troviamo di fronte a un’inedita generazione che ha bisogno di essere alfabetizzata, ma l’alfabetizzazione non è spontanea, non è come la caccia nei leopardi o nei branchi di lupi, ha bisogno di un “Maestro”. Quindi ci dobbiamo chiedere a cosa li devono educare i “Maestri” del digitale. Negli Stati Uniti hanno risposto a questa domanda affermando che l’obiettivo è quello di arrivare a pensare come le macchine in modo tale da poter interagire nel miglior modo possibile con esse ed è partito il pensiero computazionale ed il Coding. Ma si sono accorti di avere un problema, in pratica non hanno insegnanti adeguati per applicare questi programmi. In Francia, invece, hanno pensato che è più un problema di come sia l’essere umano nel tempo digitale, hanno parlato di umanità digitale ed hanno sviluppato dei programmi.
Ma anche qui il problema è lo stesso, si sono resi conto di non avere professori preparati per tutto questo. Noi in Italia forse siamo un po’ più in ritardo, perché non ci siamo ancora posti fino in fondo questa domanda, se non in contesti come questo. Dobbiamo innanzitutto avviare un dibattito su questo argomento per cercare di dare la migliore risposta possibile e, allo stesso tempo, pensare quali caratteristiche necessitano coloro a cui sarà demandato il compito di fare il “Maestro” di questa generazione.
A questo punto le chiedo cosa voglia dire essere insegnanti di Coding?
Il Coding di fatto è una tecnica. Cerco di spiegarmi con un esempio, per amare la montagna è sufficiente conoscere tutte le tecniche del CAI o degli alpini? È chiaro che se uno conosce queste tecniche può andare in sicurezza in montagna, ma tutto quello che serve per ammirare un bel paesaggio e per capire dove voglio andare quando vado in montagna è richiesto da cose che non sono competenze tecniche, ma sono stature morali della persona. Quindi, insegnare Coding vuol dire dare una tecnica, ma il Coding deve essere inserito all’interno di questo processo più ampio di cura della persona perché non rimanga una tecnica muta ma sia uno strumento che permetta ai ragazzi di diventare le donne e gli uomini che desiderano essere.
Un’ultima battuta, lei spesso parla di un’etica negli algoritmi e nella tecnologia che deve essere pensata prima di mettere in atto le scelte. In particolare qual è la differenza di approccio tra scrivere un algoritmo e programmare in un linguaggio come ad esempio il Python?
È un approccio che chiamo “by design”. In pratica la nostra non deve essere un’azione che va a mettere una pezza ad un qualcosa che già è in atto, ma deve essere pensata a priori per evitare di rincorrere qualcosa che poi ci sfugge di mano. Il principio che dobbiamo adottare, che è alla base del pensiero degli ingegneri, è sintetizzato in “misura due volte e taglia una volta sola”, che sta ad indicare di pensare bene a quello che si sta per fare per prevederne tutte le conseguenze possibili. L’algoritmo è un pensiero mentale, è ottenere una selezione in un numero finito di passaggi, mentre il Python è il linguaggio che consente di farlo ad un computer. Ma è chiaro che se io non penso prima, cioè non sono uomo, poi non posso istruire la macchina. L’etica, che è la parte più nobile dell’umano, va applicata a tutto l’uomo. Solo uomini etici realizzeranno poi un’algoretica, cioè algoritmi giusti e capaci di rispettare gli altri uomini.
Fabio Gervasio