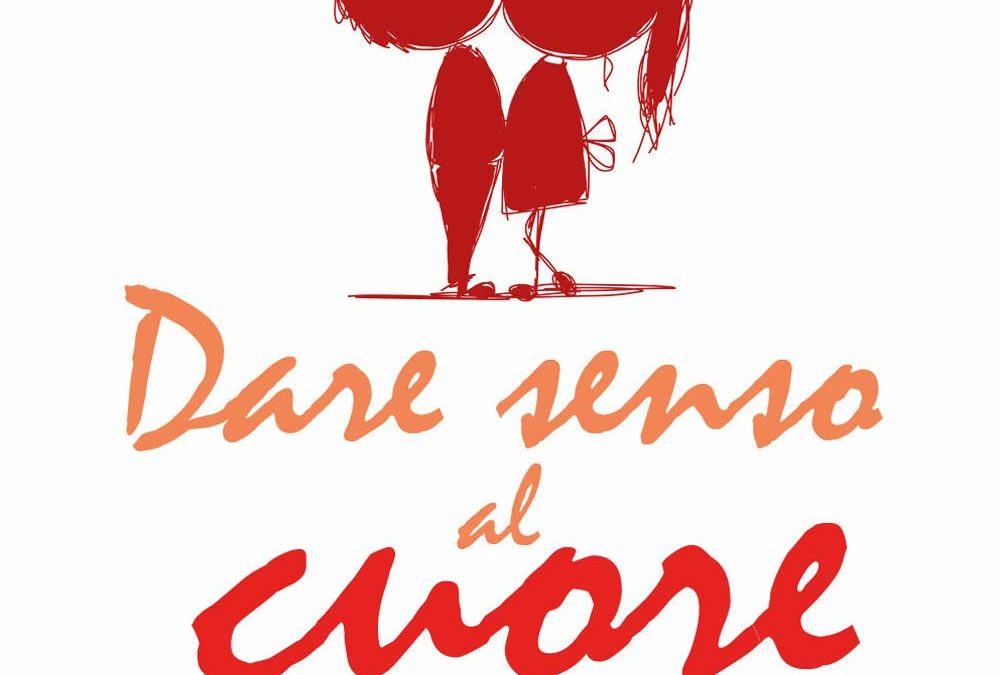Feb 29, 2024 | Home, Newsletter, Spazio cinema
Paese: USA (2002) – Durata: 101 minuti – Regia: Adam Shankman
È un bel film, tratto dall’omonimo libro, ben strutturato, con avverbi usati sapientemente. Una storia dai toni relistici, che in un modo o nell’altro può ripetersi anche tra i nostri banchi di scuola, tra i nostri ragazzi.
Si tratta due giovani, Landon e Jamie, che non si sono mai parlati, sebbene si vedano tutti i giorni fin dall’asilo. Hanno un solo denominatore comune: la sofferenza. Landon per essere stato abbandonato dal padre, e Jamie per aver perso la madre e per un motivo che si trova al primo posto di una lunga di desideri, 42 per l’esattezza, quasi mai realizzati. Lui sembra un ragazzo qualunque, lei la classica bigotta d’oltre oceano. Ma non è così.
Tra molti alterchi, sciocche risate da parte dei vari personaggi, e disgustosi scherzi degli amici di Landon, bene o male i due si innamorano.
La storia finisce male… o forse no, perché l’obiettivo numero uno si avvera.
Auguro la visione a tutti noi, sia in casa sia a scuola.
Michael Dall’Agnello
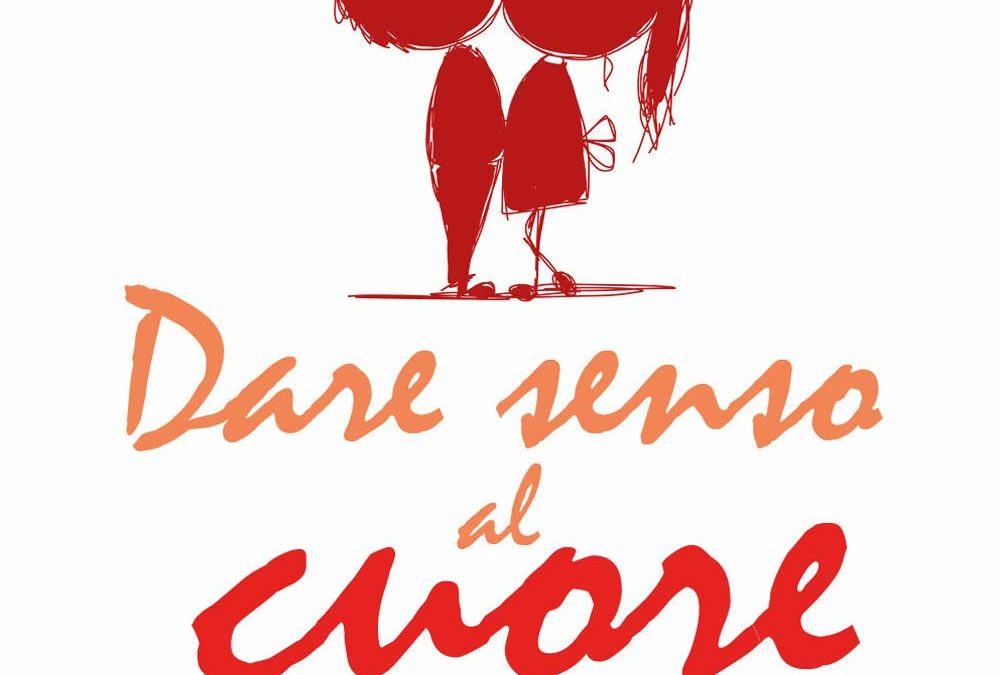
Feb 29, 2024 | Home, Invito alla lettura, Newsletter
Saverio Sgroi – Dicembre 2018
Questo libro è il frutto di anni di incontri, confronti, colloqui con centinaia di genitori che, con modalità ed esigenze ogni volta diverse, hanno fatto sempre la stessa domanda: come parlare di sessualità ai nostri figli? Una domanda che, a detta dell’autore, non potrà mai avere una risposta univoca per tutti. Il testo è rivolto soprattutto a genitori con figli adolescenti e preadolescenti, ma ne è consigliata la lettura anche a quei genitori che hanno figli più piccoli: il rapporto con i figli adolescenti, infatti, non si improvvisa, ma si prepara con largo anticipo!
Ciascun capitolo approfondisce un aspetto specifico dell’educazione affettiva e sessuale, non solo con elementi teorici ed esperienziali necessari a comprendere meglio alcuni concetti importanti, ma fornendo anche strumenti di lavoro che aiutino i genitori nel rapporto con se stessi e con i figli.
Di educazione all’affettività si parla ormai insistentemente da decenni, ma mai come in questi ultimi anni essa è diventata assolutamente necessaria. Secondo l’autore è importante che i genitori sappiano dedicare le loro migliori energie per essere in grado di educare la sessualità dei propri figli per aiutarli a coglierne il nesso inseparabile con l’amore. La sessualità, infatti, coinvolge tutte le dimensioni della persona: non solo quella fisica ma anche quella razionale, quella affettiva, quella relazionale ed infine la dimensione spirituale.
Educare l’affettività, in particolare, è quell’arte specialissima che vuole dare senso a ciò che accade nel cuore dei figli. Senso inteso come significato ma anche come direzione: educare l’affettività vuol dire quindi aiutare i figli a riempire di significato ciò che provano nel cuore quando amano, anche attraverso la sessualità.
Michela Spiazzi

Feb 29, 2024 | Articolo di fondo, Home, News Homepage, Newsletter
Intervista a don Daniele Dal Bosco, parroco, insegnante di Religione Cattolica e tutor Teen Star.
Da diverso tempo, inizialmente nelle scuole medie ma poi anche alle elementari e a catechismo, si sono introdotti progetti di educazione sessuale o educazione all’affettività, in cui vengono chiamati esperti, da medici a psicologi e sessuologi, per introdurre e guidare i bambini e i ragazzi al mondo della relazione con l’altro sesso. Però non è sempre stato così.
- Cosa significa “Educazione all’affettività”, “Educazione sessuale”? Ce n’è davvero bisogno?
Il termine educazione indica la necessità tipica di ogni essere umano di essere introdotto alla conoscenza della realtà da parte di chi è più grande di lui perché non può farlo da solo (questo differenzia l’uomo dagli animali che si trovano invece già con l’istinto che gli dice tutto ma anche senza una vera libertà di scelta). Allo stesso tempo l’originale latino “ex-ducere”, dal quale il termine italiano deriva, indica che per essere vera e non indottrinamento l’educazione deve aiutare a cogliere e scoprire la reale struttura della persona dandogli strumenti perché si possa creare un giudizio sulle cose.
Anche per quello che riguarda l’affettività e la sessualità, che sono i fondamenti della persona in quanto ognuno desidera amare ed essere amato, è fondamentale che chi si affaccia alla vita possa essere aiutato a comprenderne la bellezza e complessità. Quando ero adolescente ricordo di aver visto una mostra di miei coetanei che speravano “Ci fosse un Maestro…” per scoprire la vita e oggi certamente l’esigenza non è venuta meno, anzi. Inoltre, il bisogno non c’è solo da parte di chi viene educato, ma anche dell’educatore perché, nel farlo, riscopre anche per sé la bellezza e la verità di quanto vuole trasmettere; come devono fare gli insegnanti che quando spiegano qualcosa agli alunni la devono prima di tutto chiarire a sé stessi.
2. Esiste un “troppo presto” o un “troppo tardi” per affrontare la questione?
A mio parere il rischio prevalente di oggi è che si arrivi troppo tardi per mancanza di una proposta da parte degli adulti e questo, come sempre più dimostrano le risposte che i ragazzi danno durante i percorsi Teen Star che propongo a scuola e in parrocchia, li porta a farsi un’idea o attraverso il confronto con i coetanei o peggio ancora attraverso internet e i social media che spesso hanno una visione riduttiva se non distorta della questione.
3. Qual è il compito dei genitori? E’ bene che se ne occupino o è meglio che ne stiano fuori?
Quando si parla di educazione i genitori non possono mai chiamarsi fuori perché, anche lo volessero fare, i figli vedono l’impostazione e le scelte che fanno e questo è già una proposta. Come diceva papa Benedetto XVI, anche se possono far apparire il contrario, in realtà, nel loro intimo, i ragazzi e giovani non vogliono essere lasciati soli di fronte alle sfide della vita. Ma per citare un altro Pontefice, Papa Francesco, per educare un ragazzo ci vuole un villaggio. Quindi è fondamentale che, oltre ai genitori, ci sia una rete educativa fatta da scuola, parrocchie e altre agenzie educative dove possano essere supportati e consigliati nel loro compito che rimane, però, insostituibile. Un rischio che posso però vedere sta nell’utilizzare un tipo di proposta deduttiva tipo “queste sono le regole”, “questo è il giusto e tu devi adeguarti” che rischia di far percepire il tutto come un’imposizione dall’esterno; una proposta adeguata, invece, dovrebbe partire dalla fiducia che il ragazzo ha un cuore fatto per riconoscere la verità e quindi aiutarlo a conoscersi nei propri aspetti biologici, intellettuali, emotivi, sociali e spirituali, per capire chi è e perché esiste. Come diceva William B. Yeats, quando si educa qualcuno si tratta non di riempire un secchio ma di accendere un fuoco.
D’altronde fa parte dell’esperienza educativa che, dopo che si è fatto di tutto per proporre ciò che si ritiene vero per la vita, si deve lasciare il tempo e la libertà all’educando di verificare e scegliere se seguire questa proposta. In fondo anche Dio stesso è arrivato a dare la vita per la nostra salvezza, ma proprio nel farlo ha rispettato la nostra libertà di accoglierlo o meno.
4. Come affrontare la difficile questione dell’accesso alla pornografia da parte dei ragazzi ma spesso, purtroppo, anche dei bambini?
Certamente siamo di fronte a uno sdoganamento completo della fruizione del porno trasversalmente a età, genere e area geografica e, data la latitanza educativa degli adulti, spesso rischia di essere l’unica idea che i nostri ragazzi si fanno in tema di sessualità. Direi, intanto, che sarebbe opportuno non fornire di devices elettronici i nostri bambini, in quanto non ne hanno bisogno, anzi, più sono a contatto con la realtà concreta, meglio è. In secondo luogo, bisogna che i bambini e i ragazzi non siano lasciati soli, ma abbiano la vicinanza e testimonianza di genitori maturi affettivamente e sessualmente, cioè in grado di mostrare che la pornografia è una riduzione e contraffazione dell’amore e non crea un vero rapporto ma chiude in una solitudine che non soddisfa veramente se stessi e non rispetta l’altro.
5. L’approccio cristiano ha ancora qualcosa da dire? Può competere con il mondo dei social che dà messaggi molto più immediati e gratificanti?
La proposta cristiana non solo nel campo sessuale e affettivo, ma nella sua completezza, ha dalla sua due grandi alleati: la realtà che non si fa da sé, ma è fatta da Dio e il cuore dell’uomo che è anch’esso domanda di compimento infinito. Per cui rimane vero che il mondo dei social può essere più immediato e gratificante, ma, come dice il profeta Aggeo nella Bibbia, “Avete seminato molto, ma avete raccolto poco; avete mangiato, ma non da togliervi la fame…” per cui, dopo un momento di estasi, si ricade in una solitudine ed insoddisfazione maggiore. Per usare parole più recenti, la stessa insoddisfazione nella canzone di Lady Gaga “Shallow” si manifesta nella domanda “Dimmi ragazzo, sei felice in questo mondo moderno?”
Il cristianesimo permette di guardare tutto nella sua completezza, un po’ come ammirare un quadro non standogli a due centimetri per vederne un pezzetto, ma alla distanza giusta per vedere sia quel pezzetto sia la bellezza della totalità dell’opera godendone molto di più. Sta a noi cristiani fare per primi esperienza di questa più grande soddisfazione nel vivere (il centuplo che Gesù ha promesso a chi lo segue) e, a partire da questa certezza, continuare a proporla e testimoniarla a tutti, giovani e ragazzi compresi, certi che hanno un cuore fatto per poterla riconoscere e accogliere.
Nei percorsi Teen Star mi sorprende, nei ragazzi, il passaggio da un iniziale disinteresse e scetticismo sulla loro utilità, pensando di aver già compreso tutto, ad una curiosità e sorpresa nel vedere adulti che si affiancano a loro spalancandogli una complessità e ricchezza di un mondo che non sapevano potesse esistere. Tanto da tempestarti di domande, avendo trovato finalmente un luogo dove porle e delle risposte.
Sappiamo, infine, noi educatori che c’è già Uno che nel cuore di ogni uomo ha impresso la Sua immagine e somiglianza e che non cessa anche oggi di cercarli e chiamarli a sé e, quindi, anche noi operiamo non da soli ma cooperando all’opera di un Altro che sempre ci precede e accompagna, avendo già vinto il mondo.
Miriam Dal Bosco

Feb 29, 2024 | Articolo di fondo, Home, Newsletter
Prendo spunto dal bellissimo editoriale di Andrea Monda apparso sull’Osservatore Romano del 29 dicembre con il titolo “Il coraggio di amare” per allargare la riflessione in atto nel nostro Paese sull’urgente tema della denatalità.
Quello della denatalità è in effetti il fascicolo più importante sul tavolo del Presidente del Consiglio, perché i figli sono il primo indice di felicità di una popolazione, ma soprattutto perché sono il primo investimento di uno Stato, se vuole garantirsi il presente e il futuro, dal momento che non c’è nulla come un esercito di bambini che fa girare l’economia, dagli Ospedali ai prodotti per l’infanzia, dalle Scuole ai giocattoli, dal turismo, all’abbigliamento, dalle auto alle pensioni degli anziani. Insomma, per dirla con uno slogan familiare: “No bambini, no Stato”.
Purtroppo oggi nel nostro Paese la forbice tra i decessi e le nascite si allarga di anno in anno e, come ricorda lucidamente la sociologa torinese Chiara Saraceno, “la bassa e ancora declinante natalità è innanzitutto la conseguenza del forte assottigliamento delle coorti in età potenzialmente fertile, contro un innalzamento delle speranze di vita che ingrossa le file delle coorti più vecchie. A questo vincolo puramente demografico si deve aggiungere, tuttavia, il perdurare di un tasso di fecondità che, con 1, 26 figli per donna, si avvicina al livello finora più basso, toccato nel 1995.”
“Ci vuole coraggio per amare” ha ricordato Papa Francesco nel discorso di fine anno alla Curia romana ed è proprio la latitanza di questo coraggio che ritengo oggi la causa principale del fatto che i giovani non si sposano (al massimo convivono saltuariamente) e non fanno figli (ma adottano cani dal canile).
A ogni ora il radiogiornale ci ricorda l’andamento del listino della Borsa, come fosse la notizia più importante, seguita subito dopo da qualche drammatico episodio di cronaca nera. Le belle notizie, gli alberi che crescono nel silenzio in ogni bosco, i semi sotterrati che germogliano senza far rumore, non trovano spazio nei pc delle nostre redazioni e così finisce che ci convinciamo tutti insieme che quello che conta è solo il PIL. Ma, come ha ricordato Robert Kennedy nel famoso discorso all’università del Kansas, citato da Andrea Monda, il PIL di un Paese «non comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità dei valori familiari, l’intelligenza del nostro dibattere o l’onestà dei nostri pubblici dipendenti […] né la nostra compassione né la devozione al nostro paese. Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull’America, ma non se possiamo essere orgogliosi di essere americani».
Certamente assegni familiari più generosi degli attuali dovrebbero coprire quella che secondo l’Osservatorio di Federconsumatori è il costo annuo di un figlio (oltre 7.000 euro l’anno; attualmente arriviamo a coprire meno di un terzo); certamente gli sgravi fiscali concessi all’Azienda durante il congedo per maternità della dipendente dovrebbero premiare l’imprenditore; certamente i servizi per la prima infanzia sia in termini di prodotti che in termini di scuole, dovrebbero agevolare la vita lavorativa della mamma, tuttavia il vero stimolo a fare figli è sicuramente un altro. E’ un desiderio. Vitale. Istintivo. Originario. Bellissimo.
La fertilità umana, ovvero la capacità generativa, è un gioioso e gratuito effetto sovrabbondante e per così dire collaterale di un desiderio istintivo, per dirla nel gergo biologico, che è certamente rude, ma è anche molto realistico e carico di simboli.
Il figlio non è quindi il prodotto immediato di un’attività o di un gesto della coppia. E’ piuttosto il frutto, ricercato e sperato, ma mai garantito, della volontà unitiva tra un uomo e una donna. La fecondità è il dono gratuito ed eccedente di un gesto di intimità che appartiene alla sfera affettiva, emotiva ed esistenziale delle due persone di sesso diverso che si sentono attirate a diventare una carne sola, come se questo fosse l’unico vero sogno da realizzare, pena la reciproca infelicità.
La ricerca della comunione totale e indissolubile del corpo e dello spirito è lo spazio che l’uomo e la donna dovrebbero desiderare ogni giorno per diventare quella vocazione che il Creatore ha scritto dentro la prima coppia plasmata con le Sue mani: “non è bene che l’uomo sia solo” (Gn 2,18).
Gesù conferma questa vocazione con queste parole: “Dio li fece maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie” (Mt 19,5). San Giovanni Paolo II ha individuato nell’essere maschile e femminile il significato “sponsale” del corpo, ovvero la nostra condizione esistenziale per cui non possiamo che vivere se non orientati di continuo alla comunione con un’altra persona con cui possiamo addirittura, nell’intimità, generare una nuova vita. “Siamo fatti per amare”, canta anche Nek e non si sbaglia affatto.
La depressione così diffusa nella nostra società occidentale ha le sue radici in questa mancanza di amore donato e di amore ricevuto. Per mille motivi.
“La più grande trasgressione di oggi è mettere su famiglia” rispondeva Vasco Rossi al giornalista qualche anno fa, indicando così che “la vita spericolata” è solo quella capace di condividere, che è l’unica modalità per generare futuro.
Il desiderio profondo di condividere la vita con l’innamorata fino ad arrivare a fondere il proprio corpo con il suo, all’apice dell’attrazione, è la chiave dell’esperienza umana ed è presente e vivo anche nelle giovani generazioni, perché è innato, tuttavia è coperto dalle ceneri pesanti e scure che si depositano sui nostri vestiti ogni volta che usciamo di casa e sentiamo i messaggi della cultura dominante, che ci martella con l’idea dell’indice MIBtel che non deve mai scendere e con la rivendicazione ad oltranza dei diritti individuali e di un’autorealizzazione che non passa mai attraverso il dono di sé. Anche l’omogenizzazione dei generi maschile e femminile e la loro pretesa liquidità non fanno che spegnere il desiderio che esplode solo se innescato dalla bellezza e dalla ricchezza della differenza. La rivendicata e sbandierata fluidità di genere nei film e nei messaggi che arrivano ai nostri giovani è il frutto della ricerca diabolica dell’uomo “indifferenziato”, che è neutro, sterile ed infelice.
Il nostro compito di adulti è quello di rimuovere le braci perché nei giovani si possa riaccendere la fiammella sepolta dalla cultura individualista, scartante e performante, quella che ci sporca ogni giorno con le sue fake news sulla natura umana. Noi genitori in particolare dobbiamo riappropriarci della nostra missione nativa che è quella di educare i figli che Dio ci ha donato. Non basta metterli al mondo, bisogna anche attrezzarli per la vita autonoma e come lo facciamo spontaneamente per i vestiti, l’alimentazione, lo sport, la scuola, le feste di compleanno… così dovremmo farlo per la loro vita interiore, per assecondare un rapporto sincero con se stessi, con l’altro e con Dio. Siamo storditi dal ritmo frenetico della vita moderna e quindi bisogna avere coraggio per fermarsi, sostare, perdere tempo… e dialogare con i nostri figli, su ogni cosa che ci riguarda. Perché la vita è bella? Forse anche perché possiamo perdere tempo e in questo distacco dalle urgenze troviamo la leggerezza e il fascino della nostra relazione familiare, quel sentirsi “papà” e “mamma” che ci annoda ai figli in modo fedele e indissolubile per tutta la vita. L’esperienza che facciamo di vita piena (e rilassata) ci farà trovare le parole e i gesti per insegnare ai nostri figli come si ama, senza delegare le cose belle della vita né agli insegnanti di scuola, né agli “esperti” (ma quanti ce ne sono oggi? E, fateci caso, quasi sempre senza figli).
“L’uomo – diceva il grande poeta romantico tedesco Rainer Maria Rilke – quando ragiona è un mendicante, ma quando sogna, è un Dio”. Se le ragazze e i ragazzi saranno messi nelle condizioni di sognare, perché hanno imparato a farlo osservando i loro genitori, allora sì che si uniranno per la vita e dalla loro unione nasceranno cose inaudite, perfino nuovi figli di Dio.
Prof. Umberto Fasol

Gen 16, 2024 | Appuntamenti, Conferenze
In occasione del Giorno del Ricordo il Centro Studi per l’Educazione ha ospitato la Professoressa Adriana Ivanov Danieli, esule dalmata.
Giovedì 8 febbraio presso l’Istituto Stimate si è svolto l’incontro destinato ad insegnanti e studenti per tracciare, attraverso la sua storia personale e familiare, le fila di una pagina ancora troppo poco ricordata.
Link per rivedere il video dell’incontro: https://youtu.be/hwk25HZJ8ts